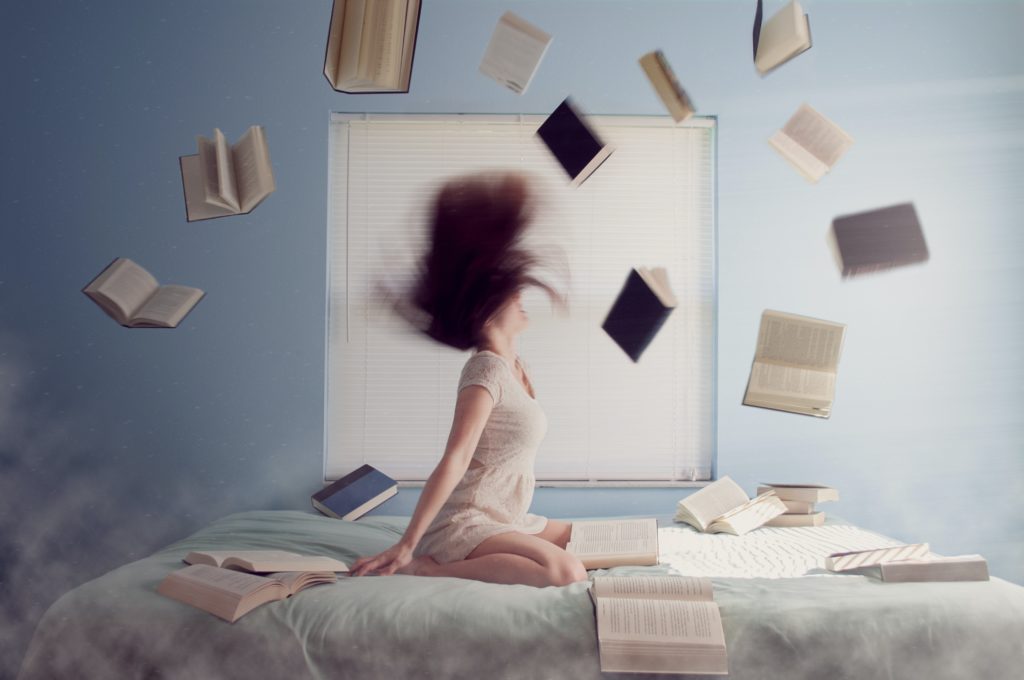di Maria Rosaria Compagnone
Il presente contributo vuole essere il primo di una serie, si spera, con cui inizia la mia collaborazione con il blog. Gli articoli vogliono ripercorrere le tappe principali del ciclo di vita, oggi iniziamo con la gravidanza.
Per scrivere questo testo è stato necessario tornare ai primissimi tempi del mio percorso professionale quando, appena laureata, mi fu chiesto di condurre dei corsi di preparazione al parto. Completamente a digiuno sul tema gravidanza, l’esperienza mi consentì di approfondire l’argomento e di apprendere nuove conoscenze.
Che cosa sia una gravidanza è ben noto a tutti, ma cosa rappresenta a livello psicologico forse un po’ meno.
L’annuncio della gravidanza porta con sé emozioni molto forti e non solo in senso positivo. All’eccitazione e alla gioia si accompagnano preoccupazioni e timori per gli innumerevoli cambiamenti che si dovranno affrontare, prima tra tutti quelli fisici.
A ben guardare, la gravidanza è l’unico evento che in assoluto apporta una tale mole di cambiamenti in un arco di tempo piuttosto breve, 9 mesi, neanche l’adolescenza, che è l’altro periodo della vita umana in cui avvengono cambiamenti significativi, è così dirompente.
L’immaginario collettivo, alimentato da un flusso di informazioni, messaggi e da un substrato culturale profondamente radicato, ci ha abituato, da un lato a considerare la donna in gravidanza come un soggetto debole, vulnerabile a causa dei cambiamenti ormonali, dall’altro come un essere felice di vivere questo “periodo di grazia” e preparata ad accogliere tutti i mutamenti che l’accompagnano. In realtà, se si pensa alla nausea, vomito, stanchezza, emorroidi, vene varicose, minzione frequente, mal di testa, mal di schiena, insonnia, limitazioni nell’alimentazione, possibili problemi di pressione, di diabete (solo per citare i sintomi più lievi), oltre al fatto che, verso la fine, ci si sente un corpo che rotola in procinto di esplodere, direi che no, la gravidanza non è sempre uno “stato di grazia” e felicità assoluta.
Ricordo che quando parlavo alle gestanti in questi termini, si sentivano sollevate perché vedevano accolto e riconosciuto un senso di inadeguatezza che provavano ma non avrebbero potuto esprimere altrimenti. Insomma, affermare che la gravidanza non è poi questo periodo meraviglioso che tutti si aspettano, non solo rende la donna impopolare agli occhi dei più, ma contrasta con l’immagine comune di una persona sempre all’altezza della situazione, che accetta prontamente ogni aspetto della condizione gestazionale.
No, la gravidanza non è così semplice!
In ambito psicologico si è concordi nel definire la gravidanza come un evento psicosomatico in cui modificazioni di tipo fisiologico, psicologico e relazionale convergono verso la costruzione del ruolo di donna-madre. Con la gravidanza, infatti, la cosiddetta funzione genitoriale dovrebbe essere definitivamente acquisita. Tale funzione, già presente in tarda adolescenza, consente di imparare a sintonizzarsi, riconoscere, regolare i segnali del bambino, a partire dalla capacità di identificarsi con una coppia genitoriale che si prende cura di un altro essere; in altre parole, la funzione genitoriale è assimilabile a ciò che comunemente chiamiamo istinto materno, solo che più che istinto, si tratta di un processo acquisito.
In questa fase spesso spontaneamente, la madre comincia un “dialogo” con il proprio bambino attraverso un linguaggio, “il motherese”, fatto di suoni, toni, parole, ritmi, accenti, configurazioni melodiche tipiche, che costituisce la base dello stile di attaccamento futuro.
La gravidanza, dunque, è un tempo di maturazione non solo del feto ma anche, a livello mentale ed affettivo, di quel profondo legame che permetterà alla donna di prendersi cura del suo piccolo e che Winnicott chiama “preoccupazione materna primaria”.
Lebovici afferma che la gravidanza è un momento di crisi in cui tendono a riemergere le fantasie relative alla propria storia infantile, il rapporto con la madre, il livello immaginario e quello relazionale, una molteplicità di pensieri e sensazioni che si esprimono con atteggiamenti incomprensibili, contraddittori ed estremi. Variabilità emotiva, paure, irritabilità, o pianti improvvisi ed immotivati, sogni vividi, sbalzi di umore, angosce di morte e preoccupazioni di malattie che si alternano a fantasie su come sarà il bimbo, sono solo alcune delle manifestazioni più comuni che chi ha avuto un figlio avrà sicuramente provato.
A proposito di fantasie, immaginare l’aspetto del bambino, le somiglianze, il sesso, il carattere, le aspettative sono le tipiche fantasie di idealizzazione che aiutano la futura madre a familiarizzare con il nascituro. Queste rappresentazioni non sono basate su specifici aspetti di realtà, ma sostenute da elementi fantasmatici che, dopo la nascita, verranno ad arricchirsi ed integrarsi in base alle interazioni con il bambino “reale” ed è molto importante che tale meccanismo avvenga perché un’eccessiva prevalenza della parte ideale sul bambino reale rischia di compromettere il corretto processo di attaccamento.
Con la gravidanza, l’inevitabile passaggio da figlia a madre comporta la riattivazione del rapporto con la propria madre, di eventuali conflitti ancora aperti, di processi inconsci di identificazione, che possono andare sia verso una risoluzione ed integrazione sia verso un loro acuirsi.

In ogni caso, diventare madre aggiunge un nuovo tassello all’identità femminile rendendola più complessa ed articolata nella varietà dei ruoli che la compongono: figlia, compagna, donna, lavoratrice e ora anche madre e, se tutto va bene, si compie l’ultimo atto del processo di separazione-individuazione chesignifica acquisire una individualità più adulta e separata dalle figure dell’ambiente circostante.
I processi psicologici descritti finora risentono anche delle significative variazioni ormonali che non agiscono solo a livello fisico, cosicché i vissuti intorno alla gravidanza possono variare enormemente.
Durante il primo trimestre, per esempio, prevale una certa passività e regressione, si ripensa alla propria infanzia, ci si identifica con il feto verso il quale si alternano gioia e timori.
Nel secondo i movimenti fetali rendono il bambino più concreto e si comincia a percepirlo diverso da sé, a relazionarsi attivamente attraverso una “danza” di movimenti fetali e stimolazioni materne.
Infine, la terza fase, quella della curiosità crescente, della consapevolezza più matura, delle interazioni dirette, della costruzione del legame materno che si conclude con il parto quando comincia un’altra storia.
Ogni donna affronta la gravidanza in modi diversi, alcune la sentiranno come uno dei momenti migliori della propria vita, altre lotteranno contro le trasformazioni del corpo, in altre ancora ambivalenze e timori prenderanno il sopravvento; nessuna sarà soltanto entusiasmante, emozionante, lineare o spaventosa ma tutto questo insieme e anche di più.
Rosaria Compagnone è psicologa www.rosariacompagnone.it