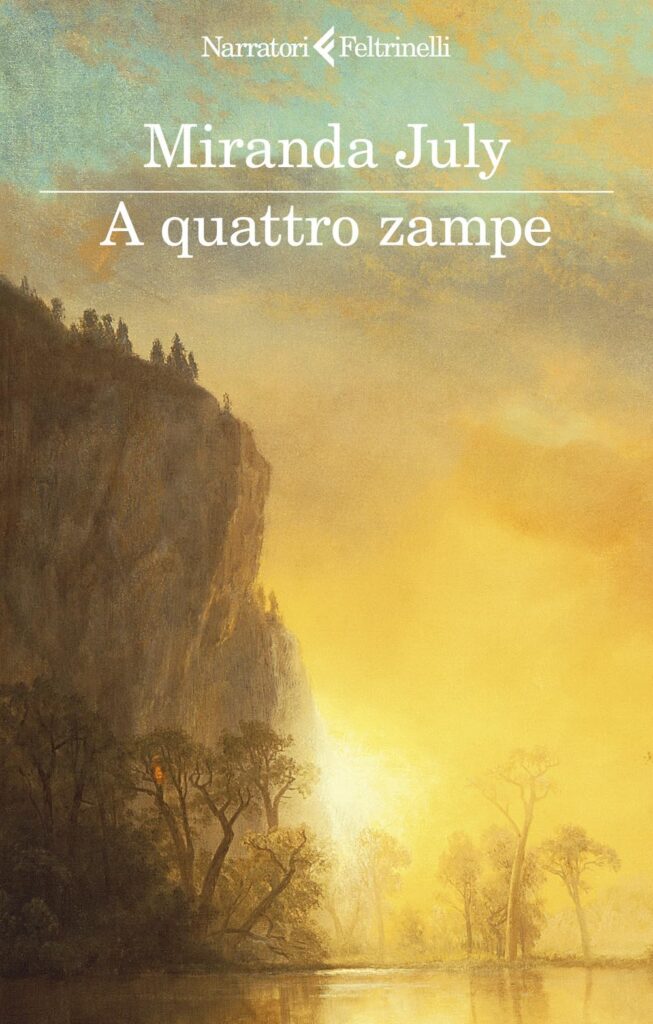Il Capodanno è una delle feste più universalmente celebrate in tutto il mondo, il momento in cui il mondo si unisce per dire addio all’anno trascorso e dare il benvenuto a quello nuovo, con l’auspicio che questo sia foriero di prosperità, salute e serenità. Tuttavia, avendo presente ciò che sta accadendo in molte Paesi del mondo (da Gaza all’Ucraina, dallo Yemen all’Etiopia, solo per citarne alcuni), è piuttosto difficile trovare argomenti di gioia per cui valga la pena festeggiare e guardare al futuro con speranza.
Il Capodanno, con le sue diverse tradizioni e rituali, dovrebbe essere un’occasione unica per celebrare la ricchezza della diversità culturale e invece, in molti casi, si è trasformato in qualcosa che ha perso il suo significato originario e che presenta un bilancio che ricorda un bollettino di guerra.
Così, Sandra, mia moglie, ed io decidiamo di astenerci da questi vuoti festeggiamenti fatti di illusioni e vane promesse e di vivere un Capodanno oltre le semplici convenzioni sociali, cercando quelle relazioni che ci permettono di essere totalmente noi stessi, senza maschere o ipocrisie.
E noi, come peraltro gli amici dell’associazione Mamre di Borgomanero con cui abbiamo condiviso molte missioni nei campi profughi in Bosnia, Libano e Ucraina, abbiamo compreso da tempo che i rapporti veri, quelli che danno un vero significato alla nostra esistenza, sono proprio quelli che nascono in mezzo a tanto dolore, solitudine, paura di essere respinti, o identificati, vedendosi così preclusa la possibilità di raggiungere parenti e amici che vivono in altri Paesi europei: tutti sentimenti che caratterizzano la condizione sei migranti.
Così, dopo aver caricato l’auto all’inverosimile di aiuti umanitari, la mattina del 30 dicembre Sandra ed io partiamo alla volta di Trieste, un viaggio che affrontiamo un paio di volte all’anno per portare la nostra solidarietà a chi, dopo aver affrontato indicibili difficoltà, raggiunge la “Piazza del Mondo” (come è stata giustamente ribattezzata dai volontari Piazza Libertà, di fronte alla Stazione ferroviaria) e spera di incontrare un minimo di umanità, di accoglienza o, quantomeno, un contesto non ostile come quello che ha caratterizzato le varie tappe del proprio percorso.
Quelli che arrivano in Italia dalla rotta balcanica sono giovani afghani, pakistani, iraniani, siriani, curdi che hanno percorso a piedi migliaia di chilometri e arrivano a Trieste con i piedi spesso distrutti a causa delle calzature inadeguate, macerati per aver attraversato fiumi o essere sprofondati nella neve, feriti dai morsi dei cani delle polizie croata e slovena, ricoperti di lividi ed escoriazioni per le percosse dei poliziotti o per le cadute nei numerosi dirupi che incontrano attraversando i boschi… (quelli che arrivano vivi!).
Rispetto al passato, la piazza appare più vivace, dinamica: oltre ai volontari di “Linea d’ombra”, che presidia stabilmente la piazza da anni con quello che ormai è diventato il simbolo, “il carrettino verde”, con il suo contenuto di materiale per medicazioni, antidolorifici e antipiretici, calzini, ma anche bolle di sapone per i bambini, ecc…, sono presenti gruppi parrocchiali di Ferrara, con Don Domenico Bedin e di Montevarchi (AR), accompagnati da Don Mauro Frasi, che con le loro cucine mobili assicurano un pasto caldo serale; il Collettivo Rotte Balcaniche Alto Vicentino, impegnata soprattutto in azioni di solidarietà sulla frontiera bulgara al confine con la Turchia; una coppia di Cuneo e altri volontari del luogo.
Fondatori di “Linea d’0mbra” sono Lorena Fornasir e suo marito Gian Andrea Franchi. Lorena, psicologa in pensione , è diventata un’abilissima infermiera che medica con amore tutte le ferite (che spesso non sono solo quelle del corpo); Gian Andrea, anche lui in pensione dopo aver insegnato per anni Storia e Filosofia in un Liceo, incontra giovani attivisti, gruppi di boy scout che arrivano da diverse parti d’Italia, giornalisti e spiega loro il senso dell’essere solidali, la valenza politica del “prendersi cura” dei migranti, ricorda i tanti che non ce l’hanno fatta, come Khobaid Bel Khalil, detto Alì, morto di confine e di necrosi, respinto nudo e senza scarpe con 20 gradi sotto zero…
Il dramma peggiore è dove queste persone sono costrette a dormire: il “Silos”, una struttura fatiscente adiacente alla Stazione ferroviaria, esposta alle sferzate di bora, con parti del soffitto che ogni tanto si staccano, la pioggia che penetra formando viscidi acquitrini, cumuli di immondizia, orde di ratti che si infilano nei pantaloni di chi dorme, lasciando morsi che spesso vanno incontro ad infezioni. In questo luogo “distopico”, sotto tende improvvisate, trovano riparo (ma è un eufemismo) circa 200 persone.
Quello che colpisce è la totale indifferenza delle Istituzioni preposte, tra l’altro, alla tutela della salute di queste persone che, vivendo in condizioni così disumane, vanno spesso incontro a polmoniti, per cui i volontari si fanno carico di portarli in ospedale o, nei casi più gravi, di chiamare un’ambulanza.
Anche molti triestini appaiono generalmente disinteressati a ciò che avviene davanti ai loro occhi, compresi molti cattolici e sacerdoti, anche se il nuovo Vescovo di Trieste, Mons. Enrico Trevisi, insediatosi lo scorso aprile, ha tracciato una nuova direzione rispetto al suo predecessore, aprendo presso una struttura parrocchiale un dormitorio con 24 posti letto e possibilità di cena e colazione per le famiglie con bambini. La sera del nostro arrivo era con noi in piazza, vestito in abiti borghesi, colloquiando amabilmente con i volontari presenti e, prima di congedarsi, ha accettato un selfie vicino a Gian Andrea, ex sessantottino, anarchico, comunista, dicendo: “C’è voluto Gian Andrea per convertite il Vescovo e i sacerdoti”.
E non c’è traccia nemmeno di quella che una volta si chiamava Sinistra.
Sandra ed io abbiamo portato della legna per riscaldarsi, alimenti a lunga conservazione (latte e farina con cui si preparano i loro “chapati“, olio, zucchero, legumi in scatola, biscotti…), giacche a vento, coperte e teli impermeabili. Sandra ed io conosciamo bene (non è la prima volta) i loro sorrisi, i loro occhi pieni di riconoscenza quando doniamo loro quel poco che possiamo, ma credo che la nostra gioia sia più grande perché quello che noi possiamo donare a loro si esaurirà in breve tempo, mentre la ricchezza della nostra esperienza esistenziale e spirituale è destinata a durare nel tempo.
E poi, non vorrei trascurare la valenza politica dell’essere lì, in piazza, a condividere il cibo, ascoltare le loro storie, medicare le loro ferite: significa affermare che essi sono persone portatrici di storie di sofferenze indicibili, “corpi-di-dolore”come li definiscono Lorena e Gian Andrea, e quindi essere lì significa riconoscere la loro umanità, opporsi all’indifferenza, o peggio al disprezzo dei molti che non vogliono essere turbati nella loro “piccola pace”, ristretta al proprio paese, a un mondo limitato; significa affermare il diritto delle persone ad essere accolte, al superamento di quelle “frontiere” non sono soltanto fisiche che non riguardano unicamente il confine territoriale, acquisendo un significato più ampio come “separazione” tra un “noi” ed un “loro”, e come limite nella costruzione di società inclusive.
Questa esperienza, da un lato consente a noi di arricchirci da un punto di vista umano, prendendoci cura delle persone non solo sostenendo i loro bisogni fisici come mangiare e vestirsi in maniera adeguata, ma anche facendo sentire loro la nostra vicinanza e solidarietà e dall’altro ci impone di gridare il loro diritto ad un’esistenza umana.