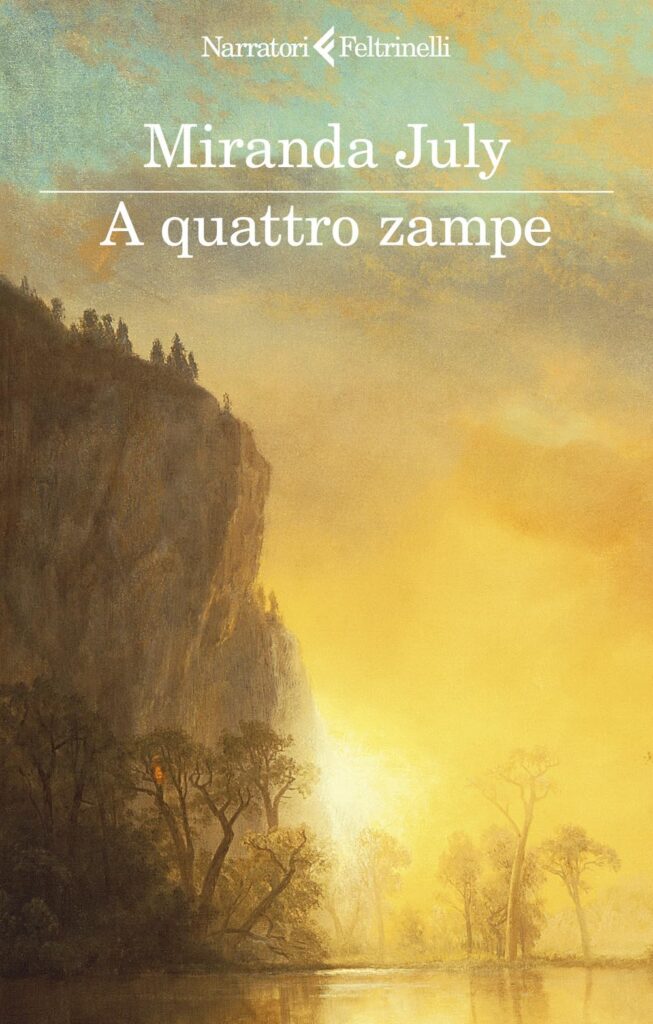Il Fast fashion (“moda veloce”) è il termine accattivante con cui i produttori e rivenditori di moda pubblicizzano un tipo di abiti “usa e getta”, di scarsa qualità e a basso prezzo, destinati a essere sostituiti rapidamente da nuovi modelli da immettere continuamente sul mercato.
Il consumatore è ovviamente attratto dalla possibilità di essere continuamente al passo con le tendenze di una moda in continuo e rapido cambiamento a prezzi abbordabili per tutti.
Il successo di questa produzione fa leva anche su meccanismi di acquisto compulsivi a cui specie il pubblico più giovane sembra particolarmente sensibile.
Il termine fu coniato dal New York Times nel 1989 quando Zara aprì il suo primo negozio a New York. Anche se il fenomeno ha le sue radici in periodi precedenti e va di pari passo con la globalizzazione dei mercati, il boom del fast fashion inizia a partire dagli anni ’90; a Zara si sono affiancati altri colossi del settore, che si sono sviluppati nel tempo abbracciando la stessa filosofia di produzione e di vendita, a partire spesso da piccole realtà artigianali.
Non si possono negare gli aspetti affascinanti di questa promessa consumistica e il suo carattere apparentemente democratico ma non si possono nemmeno ignorare i problemi di questo tipo di produzione e di consumo.
La necessità di tenere prezzi sempre bassi e concorrenziali si ripercuote prima di tutto sulle condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti. I marchi del Fast fashion sono perciò indotti a forme particolarmente odiose di sfruttamento della manodopera impiegata. Questo si traduce spesso nel trasferimento della produzione in Paesi con salari particolarmente bassi e con scarse tutele per quanto riguarda le condizioni di lavoro e la sicurezza e in cui è possibile addirittura utilizzare illegalmente il lavoro dei bambini. Il marchio cinese Shein, ad esempio, è accusato dall’Ong svizzera Public Eye di costringere i lavoratori a operare in locali privi di sicurezza, in condizioni nocive per la salute, con turni di dieci ore al giorno, con un solo giorno di riposo al mese e con salari iniqui.
Secondo uno studio finanziato dal Parlamento europeo in Cina alcuni membri di minoranze etniche cinesi, in primo luogo gli Uiguri nella regione dello Xinjiang, sono costretti a lavorare in condizioni sostanzialmente schiavistiche. Viene sottolineato in proposito l’”alto rischio”che marchi come Zara, H&M, ma anche Puma, Adidas Hugo Boss ecc. sfruttino tramite intermediari questo tipo di “lavoro schiavistico di stato”. Le rassicurazioni fornite in proposito dai marchi coinvolti non sono sufficienti a dissipare i sospetti, anche per la difficoltà di effettuare controlli sulle ditte cinesi coinvolte. Questa opacità non è accettabile anche in rapporto alla tragedia del crollo dell’edificio di Rana Plaza a Savar nel Bangladesh, del 2013, quando un edificio di otto piani, già dichiarato pericolante, in cui lavoravano in condizioni disumane 5.000 persone, collassò, causando ben 1134 morti, in maggioranza donne e bambini. Le ditte bengalesi coinvolte rifornivano marchi quali Benetton; Zara e altri.
L’industria della moda nel suo complesso genera oltre l’8% di emissioni climalteranti. Lo stesso settore produce il 20% di acque reflue complessive e occupa il secondo posto per il consumo di acqua; è del tutto evidente che il consumismo sfrenato indotto dal Fast fashion contribuisce in modo significativo a ad aggravare questi problemi ambientali.
La stessa logica di produzione dell’“usa e getta” fa sì che, secondo dati forniti da Greenpeace, nella sola Unione Europea vengono gettati via 5 milioni di capi di vestiario e di abbigliamento (12 chili a persona!) l`80% dei quali finisce in discarica o nel Sud del mondo; il 25% dell’intera produzione rimane invenduto e di esso solo l’1% viene riciclato. Alla periferia di Alto Hospicio, una città del Sud del Cile si trova una discarica dove si accumulano ogni anno decina di migliaia di tonnellate di prodotti del Fast fashion usati ma anche nuovi con un impatto altamente negativo sia per l’ecosistema della zona che per la salute degli abitanti della vicina città
I marchi della moda Fast fashion tendono a propagandare la loro produzione come sostenibile ma questo risulta poco credibile; la maggior parte dei capi di abbigliamento è realizzato con l’impiego di poliestere inquinante, che a ogni lavaggio rilascia microplastiche.
Per uscire da questa situazione è necessario che le aziende si impegnino a realizzare prodotti di migliore qualità più duraturi e riciclabili e che i governi incoraggino questo tipo di produzione. controllando che i produttori non usino materiali nocivi e inquinanti e non riciclabili e siano responsabili dell’intero ciclo produttivo.
Gli stessi consumatori, specie nei Paesi più ricchi, devono uscire da una logica compulsiva nelle loro scelte di acquisto da compiere sempre nel rispetto criteri delle compatibilità ambientali e sociali. La partecipazione degli stessi consumatori a campagne di massa per chiedere la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori può essere in altro modo efficace per costringere a un maggior controllo su tutte le fasi della produzione e della distribuzione, anche per tutelare la credibilità e la buona fama dei propri marchi.
Anche i tanto discussi influencer possono svolgere un ruolo positivo nell’orientare le scelte dei consumatori più giovani.