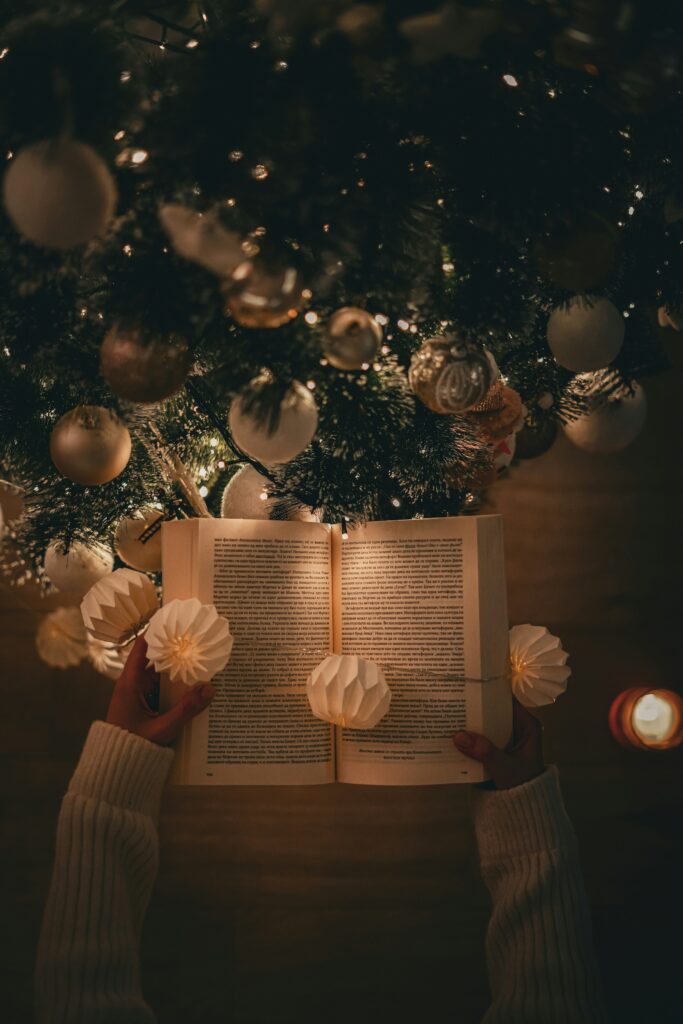C’è una pagina del Vangelo di Luca, che negli anni della mia gioventù mi aveva suscitato qualche perplessità: «In quel tempo Gesù disse: “Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto!
Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera”». (Lc 12, 49-53)
Erano parole di Gesù che disturbavano il mio modo di pensare “religiosamente corretto”; erano anni in cui vivevo la mia fede con una certa tiepidezza: “L’importante – pensavo – è andare d’accordo con tutti; la partecipazione alla Messa domenicale è una buona abitudine, ma che non mi cambia la vita; l’attenzione verso i poveri … beh, quella c’era già, insegnatami dai miei genitori”.
Poi, però, qualcosa dentro di me è cambiato, soprattutto dopo l’incontro con i poveri dell’Africa (Etiopia e Kenya): lì ho esperito emozioni che avrebbero segnato il resto della mia vita; lì ho toccato con mano la vera povertà, la sofferenza, l’abbandono di chi era ricoverato in un ospedale pubblico (nulla a che vedere con i nostri, quelli sono solo l’anticamera della morte), i neonati abbandonati per strada o le mamme che venivano a partorire davanti all’orfanotrofio dove io svolgevo la mia attività di volontariato, nella speranza che qualcuno si prendesse cura delle loro creature. Quante volte mi sono appartato, perché non volevo che altri mi vedessero, e mi sono abbandonato ad un pianto dirotto, liberatorio, per sfogare emozioni per me troppo intense e dolorose! Ma lì ho incontrato anche persone meravigliose, religiosi e laici che hanno deciso di dedicare tutta la loro vita agli ultimi.
E forse è proprio da quelle prime esperienze africane (da lì in poi ne seguiranno molte altre) che quella tiepidezza, forse solo dovuta alla cenere che copriva la brace, ha iniziato a trasformarsi in calore; quel fuoco, per troppo tempo sopito, ha iniziato ad ardere, lasciando dentro di me un senso di inquietudine che bruciava per tutte le ingiustizie e iniquità di cui ho potuto prendere coscienza e nello stesso tempo alimentava la passione per la carità, lo spirito di fratellanza. Ho capito che questo fuoco, bruciando, accende la vita stessa e la riempie di sensi, di significati; un fuoco che, quando l’hai sperimentato, vorresti si propagasse, perché c’è bisogno che divampi ovunque per cambiare le sorti di questo mondo.
E io vorrei che divampasse tra i giovani, affinché diventino gli artefici del loro futuro: un futuro ad oggi pieno di incertezze a causa dei cambiamenti climatici, delle emergenze ambientali dell’estensione dei conflitti che vedono sempre più coinvolte le grandi potenze nucleari, con il rischio della scomparsa della vita umana sul pianeta; e poi, il problema del lavoro sempre più precarizzato e con stipendi da fame mentre, per chi ha conseguito brillanti risultati nello studio, l’unica possibilità è quella di prendere la strada per l’estero.
Vorrei che divampasse nella Chiesa, una Chiesa che, nonostante papa Francesco non si stanchi di volerla “in uscita”, è ancora troppo spesso arroccata su sé stessa, incapace di aprirsi ad un dialogo vero, schietto, verso le numerose istanze che questa epoca ci mette di fronte, di combattere quelli che il Papa definisce «miti della modernità» («individualismo, progresso indefinito, concorrenza, consumismo, mercato senza regole») e di portare la buona notizia alle periferie, a tutti gli esclusi: i poveri, i migranti, i sofferenti. Egli desidera che la Chiesa venga conosciuta non per ciò a cui è contraria, ma per quello a cui è favorevole, una Chiesa che costruisce ponti.
Vorrei che divampasse tra chi, oggi, si occupa dell’informazione: troppo spesso ci troviamo di fonte a un’informazione unilaterale, pronta giustamente a condannare l’aggressione russa all’Ucraina ma restia a provare a individuare le vie di una possibile pace giusta.
Una stampa (e una politica) che spesso usa due pesi e due misure quando si tratta di giustificare le guerre degli Usa e dell’Occidente in Iraq, in Afghanistan o in Libia, che difende magari la libertà di un popolo amico e trascura o mercanteggia i diritti altrettanto legittimi dei curdi o dei palestinesi in nome di una miope Realpolitik.
Quella della stampa dovrebbe essere un’azione di stimolo e di critica costruttiva, intesa in senso positivo. Il problema in Italia è che spesso i giornalisti liberi diventano oggetto di invidie da parte dei colleghi proni ai loro direttori o proprietari. Costoro costruiscono le loro carriere insultando, offendendo, sbattendo in prima pagina il drogato disperato, il furtarello commesso dall’immigrato o altri reati che riguardino comunque chi vive ai margini della società: l’importante è che non si tocchi il potente o il politico di turno.
Infine, vorrei che questo fuoco incendiasse i cuori della società civile e della classe politica tutta affinché le scelte fossero orientate al bene comune, a principi di solidarietà e di sussidiarietà; affinché si mettano al primo posto i bisogni di chi ha meno possibilità; affinché ci sia una diffusa crescita culturale (intesa come conoscenza delle nozioni di storia, geografia, ecologia, logica, politica, economia e molto altro) che consenta la comprensione el’interpretazione della realtà da parte del singolo individuo e quindi la capacità di operare scelte che siano frutto della propria intelligenza e non dei richiami delle “sirene che si rivolgono alla sua pancia”. La politica, intesa come l’insieme di movimenti, esperienze, energie, risorse intellettuali e morali diventi uno spazio aperto a relazioni inclusive, in grado di affrontare le grandi sfide, come quella della Pace e della corsa agli armamenti; dell’equità fiscale (il contrario della flat-tax); dell’immigrazione come fenomeno che vede coinvolti non numeri, ma uomini e donne in carne ed ossa, con le loro storie, le loro speranze, le loro paure e debolezze, i loro diritti (e i loro doveri), la loro creatività, la voglia o meno di integrazione. Una politica che non punti alle grandi quanto inutili opere, ma alla messa in sicurezza del nostro fragile territorio sempre più in balìa dei cambiamenti climatici; che guardi alle fonti di energia rinnovabili che assicurino una vera indipendenza da potenze straniere, un minor impatto ambientale in termini di inquinamento di aria e acqua e surriscaldamento globale.