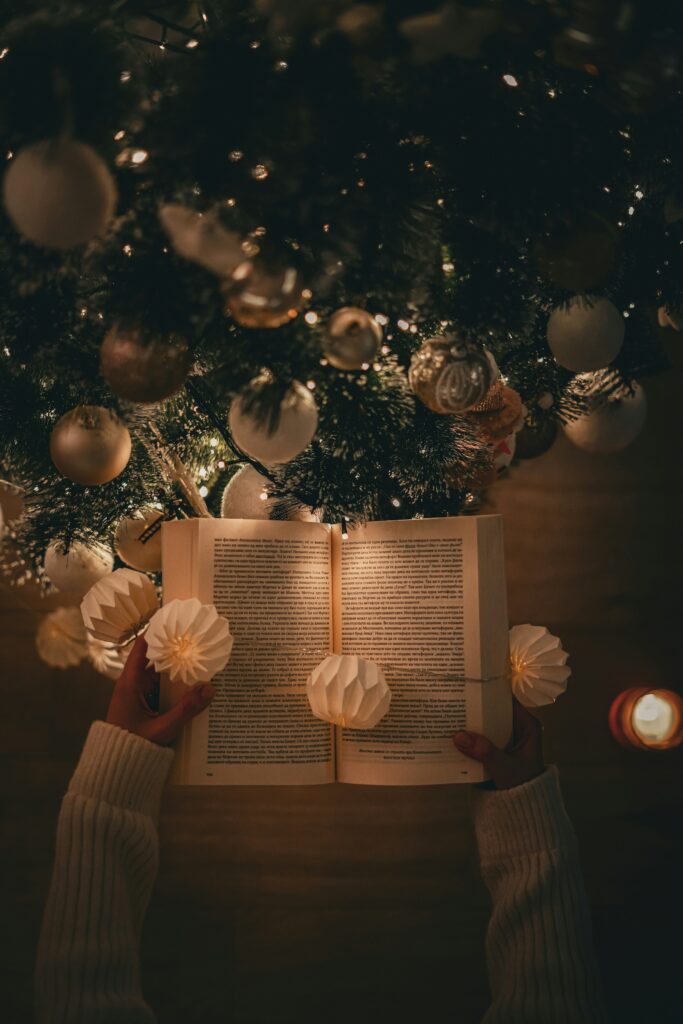Mi è tornato tra le mani, alcuni giorni fa, “I frontalieri in Europa. Un quadro storico” scritto da Paolo Barcella, docente di storia contemporanea all’Università di Bergamo. Ho ritrovato il libro proprio gli stessi giorni quando si era iniziato a discutere, in Svizzera, dell’obbligo di dover fare il tampone Covid per coloro di ritorno dall’Italia, ma non dalle regioni confinanti. Ovvio che l’elefante nella stanza, per dirla con una metafora tanto amata dagli anglosassoni (there’s an elephant in the room..) erano e sono i frontalieri.
Oggetto, a più riprese, di campagne populiste (“prima i nostri”), valorizzati da alcuni, biasimati da altri, gli italiani che conducono una vita a cavallo della frontiera di Chiasso e altri valichi di confine hanno superato quota 71’500. La pandemia di Coronavirus ha posto ulteriormente sotto i riflettori queste donne e uomini, vuoi perché alcuni di loro si sono messi a lavorare in remoto, vuoi perché altri (molti altri) hanno continuato a passare il confine. Per lavoro, si intende. Facile criticare. Condivisibile la volontà di tenere le frontiere aperte. Ma come gestire il fenomeno del frontalierato e come promuovere una discussione costruttiva tra pro e contro?
Scriveva Tucidide che “la storia è filosofia che insegna mediante esempi”. Il libro di Barcella fa proprio questo. Ci immerge nella storia del frontalierato. Ci pone di fronte fatti: i contesti storici, geografici ed economici in cui si sono mossi i frontalieri fin dall’età moderna. E ci aiuta a comprendere la portata del fenomeno ma anche come mai lungo alcune frontiere, chi le ha varcate giornalmente ha rappresentato una quota di lavoratori bene integrata nel mercato del lavoro, mentre in altri casi il frontalierato ha rappresentato (e ancora rappresenta) un fattore di grande innalzamento della tensione sociale.
Leggiamo così che già in età moderna si svilupparono le prime forme di pendolarismo internazionale, che poi nella seconda metà del ’900, grazie alla diffusione dell’automobile, si intensificarono, con evidenti conseguenze e ricadute. Fu ad esempio rivista la fascia massima di frontiera, che determinava la distanza massima entro la quale un lavoratore avrebbe potuto abitare per lavorare al di là della frontiera, la quale era stata calcolata in 20 chilometri (ridotti a 10 per alcuni cantoni), tenendo conto del tempo di percorrenza sostenibile quotidianamente per un lavoratore che si immaginava potesse spostarsi a piedi o in bicicletta. Da un punto di vista gestionale, l’accrescere del frontalierato ha posto problematiche legate alla gestione del traffico e alle infrastrutture stradali. Dal punto di vista sociale e culturale, quel flusso di persone che si muovono in un altro Paese per lavorare, senza porsi questioni di integrazione − se non nel ristretto ambito delle problematiche di pertinenza lavorativa − costituiscono un possibile fattore di tensione distinto e specifico alla natura socio-economica dei Paesi confinanti.
Leggendo il lavoro di Barcella si comprende come la frontiera abbia via via acquisito un ruolo diverso nel determinare la funzione economica che il lavoratore andrà a svolgere e come sia anche stata – spesso – un moltiplicatore di valore, ovvero abbia creato le condizioni per cui i lavoratori dall’esterno entrassero nel mercato di lavoro locale in una posizione che favoriva e abbia generato così una maggiore produzione di valore per gli imprenditori e i soggetti economici che davano lavoro.
Ciò detto, ci troviamo oggi di fronte a un cambiamento epocale conseguente alla rivoluzione informatica e l’accresciuta mobilità. Si sta aprendo, come precisa Barcella nell’ultimo capitolo del suo libro, una nuova stagione del frontalierato che riguarda la figura del lavoratore ‘notificato’, secondo gli accordi per la libera circolazione delle persone tra Unione Europea e Confederazione Elvetica del 1999. Questi lavoratori europei vengono autorizzati a lavorare in Svizzera senza permesso di soggiorno per un massimo di 90 giorni non consecutivi e si richiede loro solamente una notifica di presenza presso gli uffici competenti. E questo pone domande fondamentali su come l’introduzione dei Bilaterali Svizzera-Ue dello statuto dei “notificati” abbia cambiato il frontalierato nella Svizzera italiana…
Per chi è interessato al fenomeno storico, per i contrari ma anche per chi è favorevole ai frontalierato per partito preso, il libro storico di Barcella – tra l’altro scritto in modo molto chiaro – offre spunti di riflessione interessanti sui quali, in queste giornate di vacanze, poter riflettere. (Anche per non pensare sempre, e solo, della pandemia).