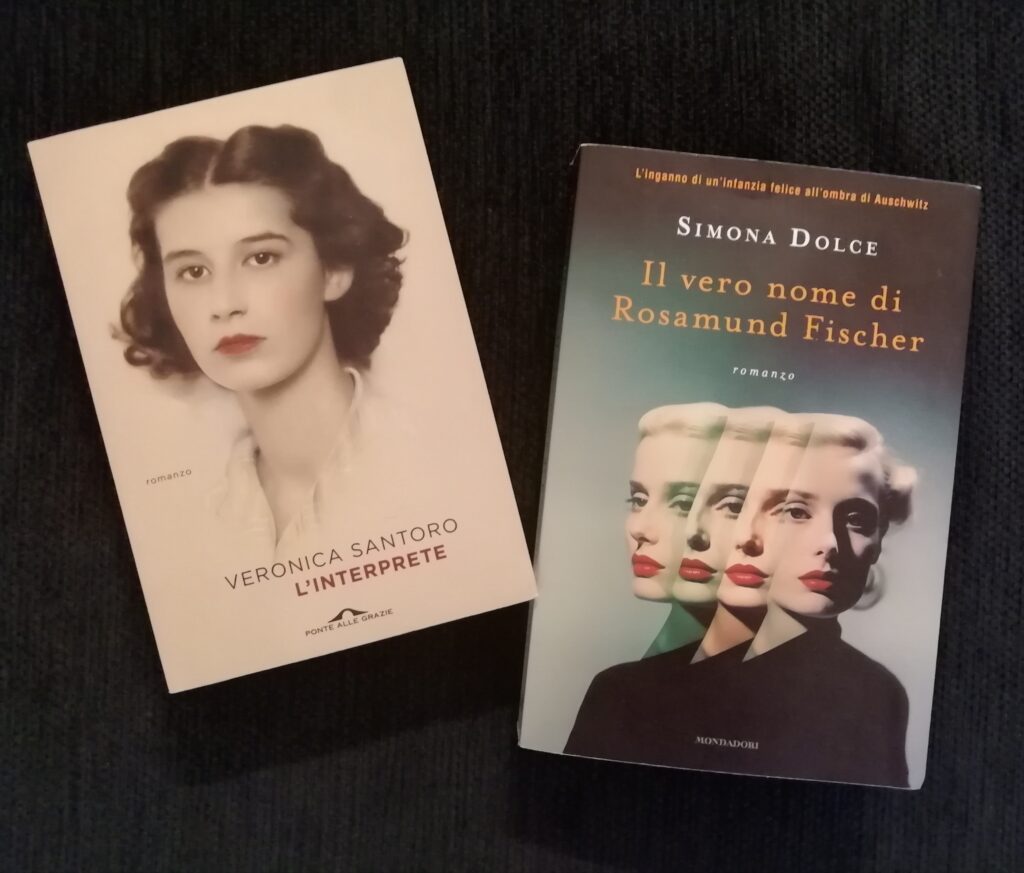Il 2023 si è congedato dimesso e affranto, con guerre e genocidi che perpetuano senza indici chiari di possibili risoluzioni e anche dal punto di vista climatico è stato sconfortante tirare le somme. Sarà ricordato come l’anno più caldo di sempre, l’anno degli eventi meteorologici estremi, delle ondate di calore, della siccità, degli incendi devastanti, delle alluvioni, l’anno della criminalizzazione degli attivisti climatici e di una delle Conferenze delle Nazioni Unite sul Clima più controverse di sempre che ha portato all’inizio della fine dell’era dei combustibili fossili, senza tuttavia mettere nero su bianco la loro eliminazione graduale.
Il 2024 si apre con grandi punti interrogativi innanzitutto per alcune elezioni importantissime, che definiranno l’impatto e la velocità della transizione ecologica e di conseguenza quanto realmente possiamo sperare nel tenere l’aumento delle temperature globali entro gli 1,5 gradi, come sottoscritto nell’Accordo di Parigi nel 2015.
Si voterà negli Stati Uniti, si voterà in Russia, in India, in Indonesia, in Messico, si voterà il nuovo parlamento europeo. Tutti luoghi, per motivi diversi, nevralgici quando si parla di cambiamento climatico, in particolare negli Stati Uniti e in Europa dove stanno guadagnando consensi candidati e forze politiche molto vicine alle aziende dei combustibili fossili che stanno cercando di far rientrare il gas e il petrolio attraverso tecnologie discusse (come la cattura e lo stoccaggio del carbonio) e potenti azioni di lobby. Tra questi c’è anche l’Italia che, col governo Meloni, ha intensificato i suoi accordi per diventare un hub del gas.
Ma se, come sempre, nel macro c’è incoerenza e forti conflitti di interessi, questo non impedisce di scovare piccole realtà locali, che con l’intraprendenza della comunità, sono state in grado di ottenere risultati eccellenti e degni di nota.
Nel cuore dell’Africa subsahariana, per esempio, una comunità di 10.000 donne sta innescando una rivoluzione in modo silenzioso e quasi inosservato. Mentre più di 600 milioni di persone in tutto il continente non hanno ancora accesso all’elettricità, queste imprenditrici determinate, note come Solar Sisters, stanno diffondendo l’energia solare e le stufe a energia pulita nelle loro comunità. Attraverso l’utilizzo di piccole lampade solari portatili hanno proposto una valida e molto più efficiente alternativa alle lampade al cherosene, spesso troppo costose per le famiglie dei villaggi e anche pericolose, sia per la salute che per l’alto rischio di incendi accidentali.
La mancanza di luce dopo il tramonto rendeva impossibile studiare o lavorare e altamente pericoloso raggiungere i bagni esterni.
La diffusione di queste lampade non solo aumenta la sicurezza delle persone, ma prolunga le ore di studio e lavoro, favorendo così anche la crescita economica, limitando allo stesso tempo l’inquinamento.
Dall’ Africa passiamo all’Europa con due esempi virtuosi. Generare calore dalle acque reflue per riscaldare le case. È quanto sta provando a sperimentare Lieven de Key, una società immobiliare di Amsterdam, che attingerà a una tubazione fognaria del distretto principale per riscaldare 1.600 case popolari, destinate a social housing e studentati.
Dopo un iniziale scetticismo, l’azienda è stata lentamente conquistata dall’idea del riscaldamento urbano, spiega il responsabile dello sviluppo Rienk Postuma. Hanno parlato con una società chiamata Liander, che costruisce collegamenti sotterranei, e con l’ente idrico, “e poi è nata l’idea di mettere pompe di calore alimentate ad acqua negli edifici, recuperando il calore dalle fogne collettive per questa parte di Amsterdam”.
Gli esperti ritengono che il calore delle acque reflue possa svolgere un ruolo importante nella transizione dai combustibili fossili. Nei Paesi Bassi ci sono altri progetti che, in genere, utilizzano impianti di depurazione o tubature di acque reflue grezze, come a Rotterdam e a Eindhoven.“Abbiamo calcolato che si potrebbe riscaldare l’8% di Amsterdam con i sistemi di acque reflue: 10.000 case”, spiega Harry de Brauw, consulente per la transizione energetica di Waternet.
Vitoria-Gasteiz invece, centro rurale dei paesi baschi, nel nord della Spagna, ha scelto una strada controcorrente e all’epoca inimmaginabile: la pedonalizzazione del centro cittadino.
Questa città, passata dai 52mila abitanti del 1950 ai 253mila di oggi, ha costruito il cosiddetto anello verde, una serie di 30 km di parchi e la prima rete di piste ciclabili della Spagna, che oggi si estende per 180 km. La città vanta 50 metri quadrati di verde per abitante, contro i 31 di Londra e i 17 di Barcellona.
Oggi Vitoria-Gasteiz è considerata leader mondiale nella politica del verde urbano e ha vinto anche diversi riconoscimenti importanti tra cui il titolo di Città verde globale, conferitole dalle Nazioni Unite nel 2019.
Infine non si può chiudere senza citare il caso della tribù dei nativi americani Cocopah, nell’Arizona sud-occidentale, dove scorre il fiume Colorado.
La regione si trova in una fase di siccità intensa da 23 anni che ha portato a razionamenti e provocato la diminuzione del 20% della portata del fiume. Uno studio dell’Università della California, a Los Angeles, ha stimato che il fiume ha perso più di 40.000 miliardi di litri a causa del cambiamento climatico dal 2000.
Lo scorso aprile, in occasione della Giornata della Terra, l’Ufficio per la protezione dell’ambiente della tribù ha avviato un progetto biennale di rimozione delle canne invasive e di piantumazione di oltre 1.000 alberi autoctoni, riportando la riva del fiume all’aspetto che aveva decenni fa. Il progetto si chiama “Final Keepers of the River” (Custodi finali del fiume): un chiaro riferimento alla tribù Cocopah, ritenuti i custodi del fiume.
L’obiettivo dei Cocopah è ripristinare più di 161 ettari lungo il fiume nella West Cocopah Reservation, a partire dal 2024, con il sostegno di 5,5 milioni di dollari in sovvenzioni da parte di gruppi federali e non profit.
La tribù dei Cocopah viveva lungo il fiume molto prima che venisse costruita la prima diga (seguita da altre 14) nel 1909 in Colorado. Queste dighe hanno impedito le inondazioni naturali necessarie per diffondere le sostanze nutritive e le sementi autoctone, decimando l’habitat fluviale e rendendo più difficile l’agricoltura. Per compensare l’impatto delle dighe sulle fonti d’acqua, il progetto “Final Keepers of the River” ha installato 1.219 metri di linee di gocciolamento per irrigare gli alberi nativi appena piantati.
Ho voluto cominciare il mio 2024 con un articolo di speranza per ogni singolo che sente su di sé la responsabilità di una crisi che sembra irrisolvibile. Il cambiamento, che sia sociale, culturale o di altra natura, parte sempre dal piccolo, dall’entusiasmo di un gruppo, che poi si fa eco per altre persone, innescando circoli virtuosi che portano risultati. Forse, di fronte alla sopraffazione che proviamo, per questi tempi violenti e ingiusti, ci rimane la sensibilità del nostro sguardo, che può abbassarsi e osservare ciò che di più prossimo ci circonda. Per ritrovare la strada a volte occorre ripartire da un sentiero, piccolo ma già spianato da altri.