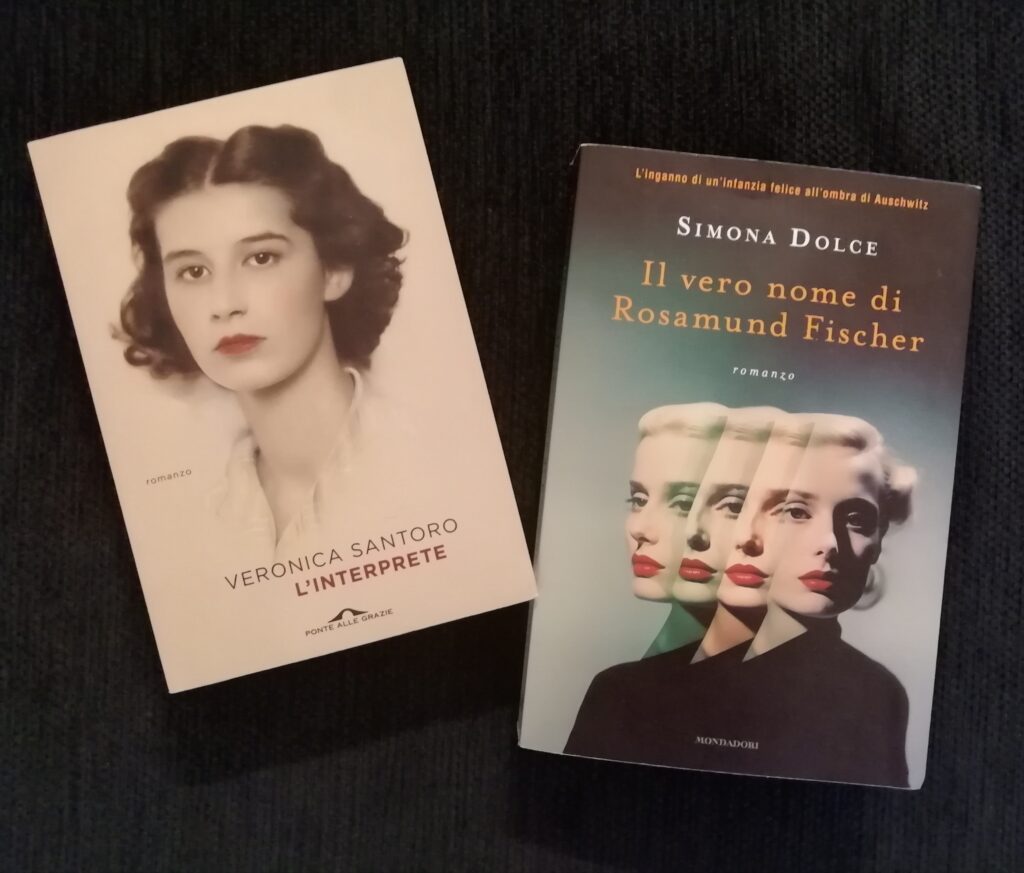Nel cuore dell’Europa, di Svizzera si parla poco, mentre l’UE in questi mesi è tornata a essere oggetto di attenzione a Berna: insomma, brevi comunicati ufficiali e istituzionali dal fronte di Bruxelles, maggiore attenzione (anche mediatica) nei cantoni elvetici. È successo a dicembre dello scorso anno, quando sono stati raggiunti e parafati dalle delegazioni negoziali gli Accordi Bilaterali III. Ed è successo di nuovo lo scorso venerdì 13 giugno quando il Consiglio federale questi Accordi li ha approvati e inviati in consultazione fino al 31 ottobre, un processo che, sempre per decisione dello stesso Consiglio federale, culminerà con un voto sul pacchetto tramite un referendum facoltativo e non obbligatorio – richiedente la sola maggioranza popolare e non la doppia maggioranza di popolo e cantoni, come stabilisce l’articolo 140 della Costituzione che riserva la doppia maggioranza a casi di adesione a organizzazioni sovranazionali (ma la Svizzera non sta chiedendo di entrare nell’UE).
Proprio anche (ma certo non solo) in virtù del coinvolgimento popolare previsto, affinché si parli fin da subito in modo corretto del contenuto dei Bilaterali III, è stata organizzata lo scorso 12 giugno dall’Ass. Osservatore Democratico in Canton Ticino una serata di dibattito che ha avuto come relatore d’onore Philippe Nell, professore, ambasciatore onorario, vicepresidente dell’Associazione “Svizzera in Europa” e membro del Consiglio della Fondazione Jean Monnet per l’Europa, autore di Négociations Suisse – Union européenne : Regard critique sur deux grands échecs et nouveaux espoirs.
Il nuovo pacchetto negoziale comprende quattro pilastri: disposizioni istituzionali per aggiornare cinque accordi di accesso al mercato in vigore dal 2002; nuovi accordi nei settori dell’energia elettrica, della sicurezza alimentare e della sanità pubblica; la partecipazione ai programmi dell’UE, anche per la ricerca scientifica; e un contributo finanziario annuale della Svizzera per progetti di coesione nei Paesi dell’Europa centrale e orientale.
La posta in gioco è alta: evitare l’erosione degli accordi esistenti e l’esclusione da programmi strategici dell’UE, come “Horizon Europe”, spiega Markus Krienke, Direttore della Cattedra Rosmini all’Università della Svizzera italiana: «Pensando proprio a un ritorno al programma Horizon Europe, ciò rappresenta un’opportunità strategica per la Svizzera, poiché consente alle università, ai centri di ricerca e alle aziende svizzere di partecipare a progetti di punta nel campo dell’innovazione e della scienza a livello europeo. Si tratta di un vantaggio competitivo che pochi altri partner esterni all’UE possiedono. Certo questa apertura pone interrogativi sulla coerenza tra partecipazione a Horizon e la politica universitaria svizzera, in particolare sul fatto che alcuni atenei impongono tasse universitarie più elevate agli studenti provenienti dall’UE. Si tratta di un paradosso che solleva dubbi sull’equità e sulla reciprocità in ambito accademico e tocca un tema che si inserisce nel dibattito più ampio sulla libera circolazione delle persone, sul timore di dumping salariale e sull’immigrazione di lavoratori stranieri.»
Ma cosa dicono i dati circa questi timori? Raccontano una realtà diversa, come ha spiegato Philippe Nell: «Nel 2023, il 27% della popolazione svizzera era di nazionalità straniera. Gli stranieri rappresentano il 34% della forza lavoro e sono essenziali per mantenere la prospettiva economica del Paese, soprattutto in settori strategici come la sanità e la manifattura. Il calo demografico – con soli 6.000 nuovi cittadini nel 2024 – rende impensabile coprire il fabbisogno di manodopera solo con la crescita naturale. I salari non hanno subito un calo: grazie alle convenzioni collettive tra sindacati e datori di lavoro, le condizioni di lavoro sono rimaste protette. L’accordo raggiunto il 21 marzo 2025, dopo oltre 80 incontri, tra sindacati e padronato, ha consolidato misure interne di compensazione che tutelano i salari e la competitività.»
Un altro tema sentito è quello della neutralità svizzera, anche se questo timore utilizzato da chi si oppone ai Bilaterali III non è giustificato: il Consiglio federale infatti ha già chiarito che il pacchetto di accordi non ha alcun impatto sulla posizione di neutralità, né implica impegni nel campo della difesa, anche se, ha fatto notare Nell, «il nuovo contesto geopolitico, segnato dall’aggressione russa in Ucraina, offre un motivo per un aggiornamento della politica di sicurezza.»
Vi è poi il delicato tema della Corte di giustizia dell’Unione europea, “accusata” da alcuni di compromettere la sovranità giuridica svizzera. Si tratta però di un altro falso mito. «Il meccanismo previsto limita fortemente l’intervento della Corte, che è chiamata a esprimersi solo su questioni di interpretazione del diritto europeo in casi estremi e attraverso un tribunale arbitrale paritetico. Inoltre, anche per ciascuna modifica normativa relativa ai sei accordi sul mercato interno, la Svizzera manterrà la propria autonomia decisionale. È previsto un periodo di due anni per l’adozione dinamica del diritto, con la possibilità di estendere questo termine di un ulteriore anno in caso di referendum», spiega Nell. «La Svizzera ha facoltà di non applicare una decisione, accettando eventuali misure di compensazione proporzionate da parte dell’UE — aggiunge Filippo Giuffrida, Direttore dell’Istituto Europeo di Studi Giuridici e di Comunicazione — Da anni, peraltro, i tribunali svizzeri già applicano la giurisprudenza europea nei casi in cui la Svizzera ha adottato norme UE, per garantire coerenza e uniformità.» Allo stesso tempo, precisa Nell, la Svizzera ha ottenuto numerose e importanti eccezioni escluse dall’obbligo di adozione dinamica, un obbligo che è già presente in accordi precedenti, come quello sul trasporto aereo (Accordi bilaterali I) e l’accordo Schengen/Dublino (Accordi bilaterali II), in vigore rispettivamente dal 2002 e dal 2008, senza aver causato problemi. Con il referendum del maggio 2019, ad esempio, il popolo svizzero si è espresso sull’integrazione della direttiva europea sulle armi nel diritto svizzero.
Ma allora, a che pro un nuovo pacchetto di accordi bilaterali? Non basta forse l’accordo di libero scambio del 1972 tra Svizzera e UE per l’economia, magari abolendo anche i Bilaterali I? Come ricorda anche economiesuisse l’abolizione dei Bilaterali I comporterebbe la perdita di numerosi vantaggi concreti per la Svizzera: dall’introduzione di nuovi ostacoli tecnici al commercio di prodotti industriali, al fatto che i diritti di traffico aereo non sarebbero più garantiti e l’export di frutta e verdura svizzere verso l’UE richiederebbe certificazioni aggiuntive. Le imprese svizzere perderebbero la possibilità di partecipare in condizioni di parità alle gare d’appalto pubbliche nelle città e regioni dell’UE e l’assunzione di manodopera europea diventerebbe molto più complessa e burocratica. Infine, i cittadini svizzeri vedrebbero limitato il diritto di vivere, lavorare e studiare liberamente all’interno dell’UE. E questi sono solo alcuni degli effetti potenzialmente negativi. Ora servono i Bilaterali III anche poiché, come ricorda Philippe Nell, molti degli accordi tra la Svizzera e l’Unione Europea sono ormai obsoleti o non più pienamente applicabili, a causa dell’evoluzione delle normative europee e dell’assenza di aggiornamenti strutturati nel tempo; alcuni sono decaduti, altri non rispecchiano più la realtà economica e politica attuale.
A fronte di tutto ciò, sottolinea Krienke, i nuovi Accordi rappresentano molto più di una serie di aggiornamenti tecnici: «si tratta di una scelta strategica sul posto che la Svizzera vuole occupare in Europa. La sua approvazione o il suo rifiuto determineranno non solo la qualità delle relazioni con Bruxelles, ma anche il futuro della prosperità economica, della ricerca (a partire da quella accademica) e della stabilità politica interna». «Oggi si parla poco di Svizzera nelle istituzioni europee e, ugualmente — nota Giuffrida — è la Confederazione stessa che pare tenere un “basso profilo” a Bruxelles. Si apre ora l’occasione per gli svizzeri di restare al centro dell’Europa e di esserlo in modo più marcatamente presente, pur da indipendenti». L’alternativa è rischiare un progressivo isolamento.