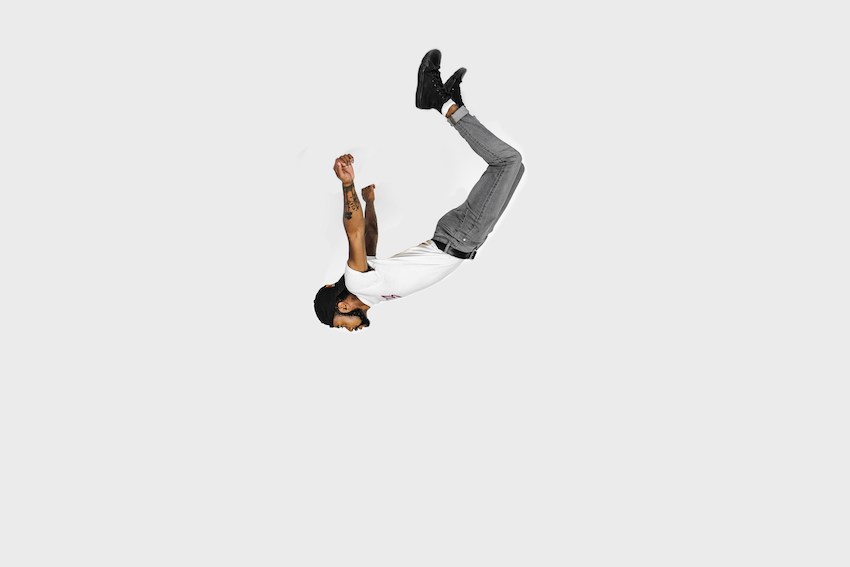Antico crocevia di traffici e commerci; luogo di transito, d’incontri e cultura, con una storia ricca e millenaria, famosa per il suo porto e le sue tradizioni culinarie. Il suo nome deriva dalle lingue semitiche e probabilmente significa “forza”, “coraggio”. La città di Gaza è una delle più antiche al mondo.
Nei secoli l’area è conquistata da vari imperi e invasori: filistei, egizi, assiri, persiani, Alessandro Magno, romani, bizantini, moghul, ottomani e Napoleone Bonaparte. Nel 1917 diventa parte del mandato britannico e nel 1948, isolata lungo la costa mediterranea dalla creazione dello stato d’Israele, accoglie duecentomila profughi palestinesi cacciati dalle loro terre.
Come ricostruisce Le Monde in un approfondimento con mappe e cartine, Gaza passa sotto l’amministrazione egiziana dopo la prima guerra arabo-israeliana (1948-1949) ed è conquistata e occupata da Israele nel 1967. Diventa il centro politico dell’Autorità nazionale palestinese nel 1994, quando Yasser Arafat, tornato dall’esilio in seguito agli accordi di Oslo, ci stabilisce il suo governo.
Quando Hamas prende il controllo totale della Striscia nel 2007, la città diventa il fulcro del suo potere. Prima del 7 ottobre 2023 ci vivevano 900mila persone: con circa 14mila abitanti per chilometro quadrato è una delle aree più densamente popolate al mondo.
Nonostante il blocco aereo, navale e terrestre imposto da Israele e dall’Egitto fin dal 2007 e le quattro guerre scatenate da Tel Aviv sul territorio (2008-2009, 2011, 2014, 2021), la città di Gaza ha continuato a pullulare di vita. Un articolo del Guardian di qualche anno fa descrive i dieci quartieri della città, ognuno “con il suo ritmo e la sua reputazione”. C’è Al Rimal, per esempio, il più carino, sede dei negozi più raffinati, delle agenzie delle Nazioni Unite e di molte ong. Vi si trovano anche gli atenei più prestigiosi – l’Università islamica, Al Azhar e l’Università Al Aqsa, che distano poche centinaia di metri l’una dall’altra – e gli edifici più alti e conosciuti. Ha sede qui anche l’ospedale Al Shifa, il più grande e importante di tutta la Striscia.
Nella città vecchia si trovano molti siti storici, tra cui la moschea Omari, uno dei principali simboli del passato millenario della Striscia, e due chiese importanti: quella anglicana di san Filippo e la greco-ortodossa di san Porfirio. Poco lontano il mercato Al Zawiya riempie l’aria dell’odore delle spezie e della frutta fresca.
Tutto questo non esiste più. Prima dell’alba del 16 settembre Israele ha avviato la sua offensiva di terra e presto Gaza sarà cancellata dalla mappa, come già successo ad altre città della Striscia, per esempio Rafah, nel sud. Le operazioni dell’esercito si sono inasprite dall’inizio di agosto, quando Tel Aviv ha approvato un piano per prendere il controllo totale della città. Nell’ultima settimana sono stati rasi al suolo gli edifici residenziali più importanti come le torri Mushtaha e Al Ghafri, entrambe punti di riferimento nel quartiere Al Rimal.
Già vedere palazzi storici crollare sotto le bombe, basterebbe a proporzionare la misura del danno. Ma non sono gli edifici, per quanto antichi e di valore a definire una città. Sono i suoi abitanti, con le loro storie, i loro background culturali, le loro speranze e ambizioni a raccontare ancora di più cosa significhi annientare un popolo e le sue generazioni.
Ci siamo mai soffermati in questi mesi a pensare cosa ne è stato, per esempio, delle centinaia di studenti che prima del 7 ottobre abitavano quelle università, con i loro progetti e vite relativamente simili a quelle dei “nostri” studenti?
Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale ha scritto un articolo in cui racconta la situazione di alcuni di loro, disperatamente in attesa di un visto, dopo aver ottenuto borse di studio umanitarie presso gli atenei italiani.
Per esempio Naim Abu Saif, un ragazzo di ventidue anni che prima che cominciassero i bombardamenti israeliani studiava e voleva diventare un giornalista. Dopo il 7 ottobre 2023 ha cominciato a raccontare online quello che gli stava succedendo e che viveva insieme alla sua famiglia.
Il suo racconto ha colpito l’attenzione di una piccola casa editrice italiana, Another coffee stories, che ha deciso di tradurre la sua testimonianza e farne un libro: L’ultimo respiro di Gaza.
Il ronzio dei droni, le bombe, la paura di morire, la nostalgia di Jaffa (la sua città natale), gli sfollamenti estenuanti, la vita quotidiana, prima in una scuola fatiscente dell’Unrwa diventata un rifugio per i profughi, poi una tenda.
Dopo aver pubblicato il libro a luglio, la casa editrice ha capito che poteva fare di più e con l’aiuto della scrittrice e attivista Maria Grazia Patania che coordina il progetto Fiori dai cannoni ha chiesto al ministero degli esteri italiano un visto di studio per Abu Saif.
Successivamente l’organizzazione è venuta in contatto con un’associazione di studenti locali Gaza students beyond borders che nel giro di pochi giorni ha inviato centinaia di richieste di aiuto di ragazze e ragazzi tra i venti e i ventiquattro anni, tutti studenti dall’ ingegneria, a medicina, alle comunicazioni. Molti di loro avevano già ottenuto delle borse di studio del programma Italian universities for Palestinian students, ma avevano avuto dei problemi burocratici con il visto.
“Ci arrivano ogni giorno messaggi strazianti”, racconta Patania, “Le persone potrebbero perdere la vita in ogni momento, a volte non riusciamo a metterci in contatto con loro e temiamo che sia successo il peggio. Riceviamo ogni giorno richieste pressanti da persone disperate, sappiamo che l’Italia potrebbe fare molto e invece ci scontriamo con un muro”.
Le associazioni chiedono al governo italiano di organizzare un trasferimento sicuro degli studenti e di qualificare l’operazione come missione umanitaria coordinandosi con i rettori degli atenei coinvolti.
Il blocco dei visti è stato denunciato anche da un gruppo di avvocati dell’associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), raggiunta da varie richieste di aiuto di famiglie della Striscia di Gaza. Ma il governo non è ancora intervenuto.
“È inaccettabile il silenzio del consolato italiano a Gerusalemme , del ministro degli affari esteri e del governo di fronte agli ordini di rilascio di visti umanitari” afferma l’Asgi in un comunicato.
Sembrerebbe che il consolato italiano a Gerusalemme ha aperto dei fascicoli ma le autorità italiane dicono che l’evacuazione umanitaria dipende da quelle israeliane, che devono autorizzare la partenza delle persone a Gaza.
Il nodo dunque sembrerebbe essere la mancata autorizzazione degli israeliani per consentire evacuazioni umanitarie convalidate da diversi articoli della costituzione.
È inquietante realizzare il paradosso cui ci troviamo davanti, dove uno stato occupante impone l’evacuazione di Gaza senza però concedere alle persone di lasciare la Striscia neppure se supportati da borse di studio e organizzazioni internazionali in grado di sostenere gli spostamenti.
Così un’intera generazione di futuri medici, avvocati, insegnanti, ingegneri, giornalisti, rimane intrappolata in una terra che brucia e crolla, a testimoniare un genocidio che si sta perpetuando anche con il potere della burocrazia nelle mani sbagliate.