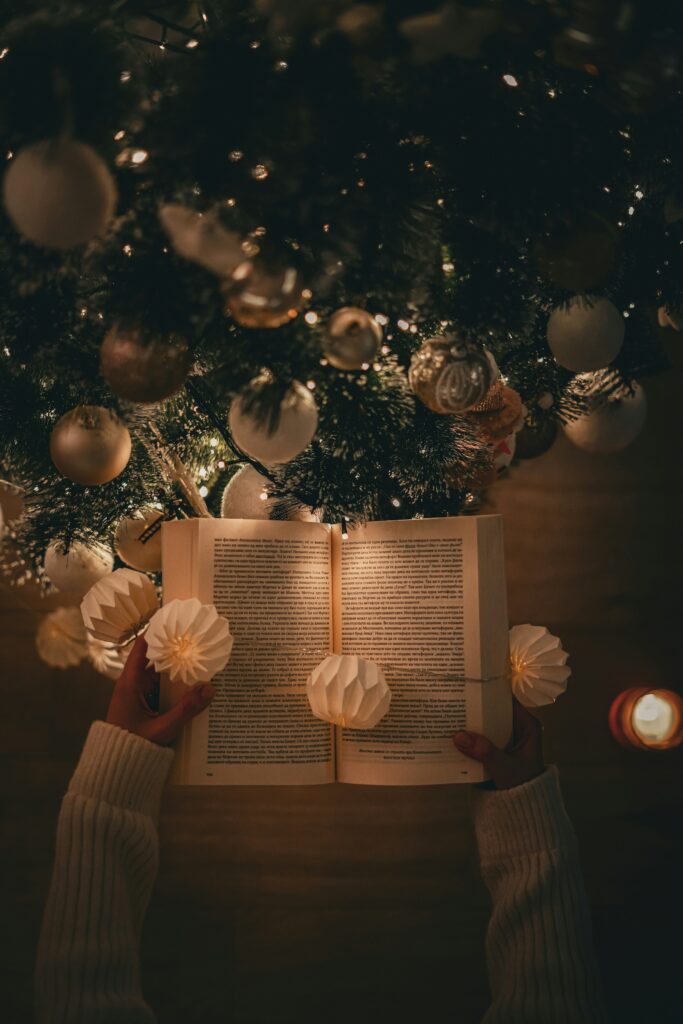“Metti in ordine la tua stanza, guarda cha ambaradan!” “Solo lei è in grado di far fronte a un simile ambaradan”. Molti avranno sicuramente usato o sentito la parola“ambaradan” che, con un tono di scherzosa leggerezza, fa riferimento a una situazione confusa o particolarmente complessa.
Non tutti però ne conoscono l’origine, che rimanda a un episodio storico su cui in realtà c’è poco da scherzare.
Ambaradan, infatti, è una deformazione di Amba Aradam, il nome di un altopiano dell’Etiopia in cui nel 1936 si svolse una sanguinosa battaglia fra le truppe coloniali italiane, guidate da Badoglio, e le truppe etiopi.
In questa zona montuosa l’esercito italiano riuscì a prevalere, facendo uso anche di gas, fra cui l’iprite, già allora condannati dalle convenzioni internazionali.
Tre anni dopo, gruppi partigiani ma anche civili etiopi si rifugiarono in una grotta di quelle montagne, da cui l truppe italiane tentarono di stanarli, utilizzando di nuovo gas e lanciafiamme ma, non riuscendo a raggiungere l’obiettivo, decisero di murare l’ingresso della grotta, condannando così a una morte atroce chi vi aveva trovato rifugio, mentre gli etiopi che si arresero furono fucilati sul posto.
Su quelle montagne il colonialismo italiano scrisse dunque una delle pagine più infami della sua già ingloriosa storia. “Peggio di Marzabotto, peggio di Srebenica” commentò Paolo Rumiz quando, nel 2006, lo storico Matteo Dominioni, al termine di una tenace ricerca, portò alla luce con prove inoppugnabili quest’ultimo episodio, dimostrando anche che la feroce repressione della resistenza etiope era stata ordinata dallo stesso Mussolini.
È noto che in Italia non è avvenuta, nel secondo dopoguerra, una profonda elaborazione del passato fascista, di cui anche il colonialismo è un aspetto non secondario. Come sottolineava Susanne Scholl, discutendo in questo blog del suo recente libro, si tratta di un fenomeno che riguarda anche altri Paesi che hanno partecipato alla barbarie nazifascista; la mancanza di questa elaborazione critica incide in modo fortemente negativo anche sulla realtà odierna dell’intera Europa.
Questa riflessione, riferita in particolare al colonialismo italiano, richiederebbe un approfonditamento che qui non è possibile. Mi limito a osservare come l’insufficiente confronto con gli aspetti più oscuri delle vicende nazionali del secolo passato abbia portato a conservare acriticamente anche nel linguaggio e, come vedremo brevemente, nella toponomastica, cascami di un passato che meriterebbe di essere rimesso radicalmente in discussione.
È evidente che il termine ambaradan nacque in epoca fascista, in un momento di esaltazione dei successi coloniali che contribuirono in modo rilevante ad assicurare il massimo consenso al regime fascista. Nel clima di esaltazione nazionalistica fu coniato anche il termine ambaradan, la cui superficiale leggerezza negava la drammaticità dell’episodio storico da cui traeva origine, depurandolo del sangue di tanti innocenti per ridurlo a un momento di confusione dovuto ovviamente all’ostinazione di un popolo “incivile” a piegarsi alla superiore civiltà italica.
A questo va aggiunto che in Italia esistono diverse vie e piazze che portano ancora oggi il nome di Amba Aradam. Spicca fra tutte via Amba Aradam a Roma, un’arteria centralissima e trafficatissima ma portano questo nome anche strade di Padova, Mestre, Civitavecchia ecc.
Proprio a Roma, nella notte fra il 18 e il 19 giugno del 2020, alcuni simpatizzanti del movimento Black Lives Matter ribattezzarono provvisoriamente la via con il nome di George Floyd.
Questi aspetti apparentemente secondari sono la spia del fatto che il mito di una presunta mitezza e umanità del colonialismo italiano si è imposto largamente come senso comune, magari in gran parte non cosciente, ma profondamente radicato anche a distanza di tanti decenni, nonostante in sede storica sia emersa in modo lampante una realtà ben diversa.
Senza entrare nello spinoso dibattito sulla cosiddetta cancel culture con le sue ragioni e i suoieccessi,apparirebbe probabilmente assurdo e velleitario imporre per legge un cambiamento linguistico; tuttavia, una presa di coscienza delle origini e delle connotazioni ambigue di questa e di altre parole potrebbe convincere molti a operare una salutare “igiene del linguaggio”, magari con la conseguente rinuncia spontanea al loro uso.
Per quanto riguarda la toponomastica, forse sarebbe ancora più significativo, anziché il cambio repentino del nome delle varie vie Amba Aradam, che molti probabilmente non comprenderebbero, apporre sotto le targhe che indicano il nome di queste strade un’iscrizione che spieghi brevemente che cosa avvenne realmente su quel massiccio montuoso solo geograficamente lontano dall’Italia
Ma questo probabilmente è illusorio in un Paese in cui personaggi politici di primo piano ci ricordano spesso e volentieri che in fondo Mussolini “ha fatto anche cose buone”.