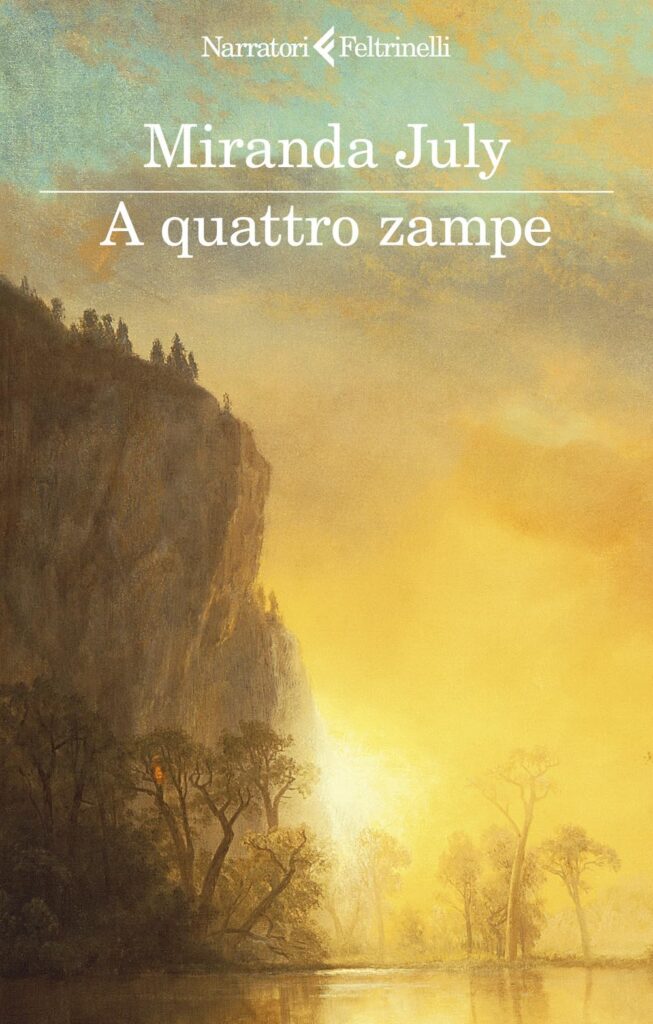È la puzza di fumo, la prima cosa che ho percepito. Anche se è strano: nel locale non è ammesso fumare. Il fumo e poi il caos. Ci vuole un attimo per mettere in ordine queste percezioni: entri, ti investe l’odore del tabacco che rimane tra i capelli e i vestiti, poi è come perdersi in un mercato, a una fiera patronale del sud, di trent’anni fa, come quelle da film.
Un vociare caotico e per nulla armonico, in una lingua che è un miscuglio di dialetti e parlate, c’è un po’ di italiano, qualche parola in francese, tanto siciliano – che io non capisco, ma che A. “traduce” per me. Mi chiedo come faccia a esserci tutto quel disordine acustico e fisico in un locale che è così piccolo: ci stanno giusto tre tavoli, che hanno però attorno molte più sedie di quante potrebbero “accogliere” e che sono disposti di fronte a un bancone dietro al quale c’è una grande macchina per il caffè, qualche bicchiere e bottiglie aperte di liquori vari. Non pare ci sia nulla da mangiare: nessuna brioche o pizzetta, che di solito ci si aspetta di poter ordinare in un posto come questo. La strada, fuori, è molto trafficata, ci sono auto in corsa, passa la linea del tram e stanno facendo anche dei lavori di lato a uno dei marciapiedi. Ma da dentro, l’esterno non esiste. È un mondo a sè, quello che si incontra entrando nel Café Milano, nel comune di Molenbeek a Bruxelles.
La prima cosa che penso è quanto poco quel bar mi ricordi di Milano!
Io e A. siamo le uniche donne nel locale. Stiamo facendo una ricerca sulla migrazione italiana in Belgio di “recente data”. Abbiamo parlato con diverse famiglie nella famosa e benestante “bolla europea” che è arrivata a Bruxelles per opportunità di lavoro. Ora ci interessa parlare con chi è giunto qui perchè costretto dalla mancanza di lavoro.
Abbiamo appuntamento con un italo-marocchino. Gli abbiamo promesso che l’intervista resterà anonima. Di lui sappiamo poco. Solo che ha acquisito la cittadinanza lavorando in Italia, paese che è stato costretto a lasciare. Siamo qui per scoprire il perchè.
Quando entriamo, quasi nessuno presta attenzione a noi. Sei o sette uomini giocano a carte. Altri sono seduti e parlano, anzi urlano. Con A. occupiamo l’unico tavolo libero, che è quello “di mezzo”. Mi guardo intorno e mi chiedo cosa facciano questi cinquantenni al bar alle 10 della mattina. Non dovrebbero essere a lavorare? “Forse fanno i turni serali”, dice A. che intanto si alza per ordinare due espresso. Propongo di andare io ma lei mi ferma e si mette a ridere. Ride perchè dice che qui, al Bar Milano, sono io “l’intrusa, la straniera”, l’unica insomma che non parla il dialetto palermitano del barista e di metà della gente che mi è attorno: “è così stretto, questo dialetto, che siamo rimasti in pochi persino in Italia a comprenderlo”. A. lo capisce, per fortuna. È nata e cresciuta a Palermo. E quella città, che ha lasciato dai tempi dell’università, le è comunque rimasta nel sangue.
Arriva la persona che siamo venuti a intervistare: direi che ha una sessantina d’anni. Il volto è solcato dalla fatica. Gli occhi invece non celano alcuna stanchezza. Esordisce con la descrizione della sua famiglia: moglie e tre figli (un maschio e due femmine, delle quali una ancora minorenne): “li sto facendo studiare tutti!”, è la prima cosa che ci dice. “Perchè hai lasciato l’Italia?”, chiedo. Risponde, senza esitare, che è stata una scelta determinata da un’ingiustizia legata al fatto che il suo capo non gli aveva concesso le ferie come da lui richiesto. Mi dice che avrebbe voluto trascorrere un po’ di tempo in Marocco, “dove c’è più libertà che in Europa oggi.”
Ma le vacanze mancate sono un pretesto. Non dice apertamente, ma è facile intuire: “Ho costruito l’Italia, io… ho lavorato sui cantieri. Ho fatto turni notturni nelle gallerie. Anni di lavoro e sudore. I miei figli sono tutti nati nel tuo paese. E sai una cosa? Dopo tutti quegli anni, sono sempre stato per tutti il marocchino. Non hanno nemmeno mai imparato il mio nome. Lo straniero“.
Però tutto era inziato bene, per lui, arrivato su una barca dal Marocco, senza documenti. Erano gli anni settanta: venne accolto dalla comunità di un piccolo villaggio locale (“a quel tempo c’erano pochi stranieri e non facevamo paura”) e riuscì quasi subito a ottenere il permesso di soggiorno: “era quello stampato su un foglio grande così” – dice mentre con le mani traccia un perimetro che a me sembra quello di un foglio A4 – “si teneva nelle tasche dei jeans e diventava subito tutto sbiadito con il sudore e il caldo”.
Come ha fatto a rimanere in Italia? Grazie al sindacato, “quello di sinistra”. Me lo dice senza giri di parole, lui che in Marocco era stato anche arrestato oltre una decina di volte per dimostrazioni contro la polizia. “Ho sempre combattuto non tanto per i miei diritti, ma per i nostri diritti. I diritti dei lavoratori. L’ho fatto in Italia come avevo fatto nella mia terra”.
È una persona determinata. Ha vissuto a lungo nel sud poi si è trasferito nel nord italiano: dalla Valle d’Aosta a Bergamo. Gran lavoratore, per alcuni anni ha avuto anche un piccolo negozio di alimentari. Lavorava di giorno sui cantieri e nel weekend vendeva frutta e verdura con la moglie.
Nel sindacato ha conosciuto quello che è oggi il PD, più grande partito della sinistra in Italia. Ma lui non è che sia proprio del PD. “Sono un simpatizzante. Nel mio cuore c’è però un nome: Romano Prodi.” E così mi racconta di aver votato per Prodi e di averne difeso le scelte politiche pubblicamente tra i suoi amici e conoscenti italo-marocchini. “Anche quando Prodi parlava di aumentare le tasse. Ho sempre pensato che solo così fosse possibile salvare l’Italia. Ho sempre pensato che se l’Italia affonda, allora saremmo affondati anche noi venuti da fuori.”
Poi è arrivato Matteo Salvini. “Tutto è cambiato. I miei figli più grandi non si sono mai davvero integrati, anche se forse ci sarebbero riusciti, chissà! Il clima di accettazione nei confronti di noi adulti è però andato decisamente peggiorando.” A Bruxelles ha trovato un nuovo lavoro. “Ora mi cercano tutti. Anche quelli del PD, sai? Mi hanno chiesto di entrare in politica. Ma io continuo a rifiutarmi. Voglio sentirmi libero di votare chi voglio, di scegliere. Oggi il PD.” E domani? “Io sto dalla parte dei lavoratori”.
Inizia a guardare l’ora. Deve prepararsi per iniziare il turno di lavoro. Il nostro tempo con lui sta per scadere. Mi saluta dicendomi “in Italia io sono cresciuto, non solo di età ma anche di cervello. L’Italia mi ha formato e sono sulle spiagge italiane che torno per le vacanze. In Marocco non vado dal 2005.”
Facciamo per alzarci quando ci ferma un signore alto, dal portamento distinto. È un italo-marocchino – come precisa lui stesso. Anche lui si è trasferito da alcuni anni, dal bolognese a Bruxelles. Anche lui per lavoro. Lo guardo e sembra commuoversi. Mi racconta che non è stato facile lasciare l’Italia. “Non c’erano più le condizioni per rimanere”. Vorrei chiedergli che tipo di condizioni siano venute a mancare, ma non trovo il coraggio. Allora lui continua: “Sei giornalista? Mia figlia si è appena laureata in Scienze della comunicazione…cerca un lavoro.” Gli dico che non saprei proprio come aiutarlo. Sembra capire, poi aggiunge che spera per lei un futuro migliore del proprio, in Belgio. Cerco di immaginarmi questa giovane, avrà amici belgi? La risposta me la offre il mio interlocutore, a sua insaputa. “Mia figlia si sente ancora molto italiana. È in Italia che ha iniziato la scuola, là le sue prime amicizie”. Ma non c’era lavoro. La famiglia non era più benvenuta. E così si è arrivati al trasferimento all’estero, a Molenbeek. Era il 2013 e nel comune bruxellese il 40% delle persone era di origine marocchina, mentre gli italiani erano (già allora) una delle comunità principali.
Mi manca l’aria. Sento di dover uscire da quel luogo. Non sostengo più quegli sguardi di gente messa ripetutamente ai margini . Il vociare è frastornante. La puzza di fumo insopportabile. Sto per aprire la porta del bar, quando qualcuno mi ferma – di nuovo – per domandarmi se sono del sindacato. Mi trovo di fronte a un uomo che parla italiano e che in due minuti mi racconta la sua storia: è un italiano, ha avuto un infortunio sul lavoro in questo paese, non ha qualifiche professionali se non quella di piastrellista, attività che non può più svolgere. “Ma con le mani in mano io non ci voglio stare”, mi dice.
Ormai sono fuori. Con la coda dell’occhio vedo che A. è stata trattenuta. Un signore vuole raccontare anche lui la sua storia, dall’Italia alla Romania al Belgio, per lavoro. “Scusa A., io scappo”, è quello che penso e chiudo la porta alle mie spalle.
Fuori fa freddo, la primavera ancora non si vede a Bruxelles. Mi tolgo comunque la giacca. Voglio liberarmi dal fumo e forse anche scrollarmi di dosso quelle storie di fatica e emarginazione che uniscono l’Italia al Belgio.