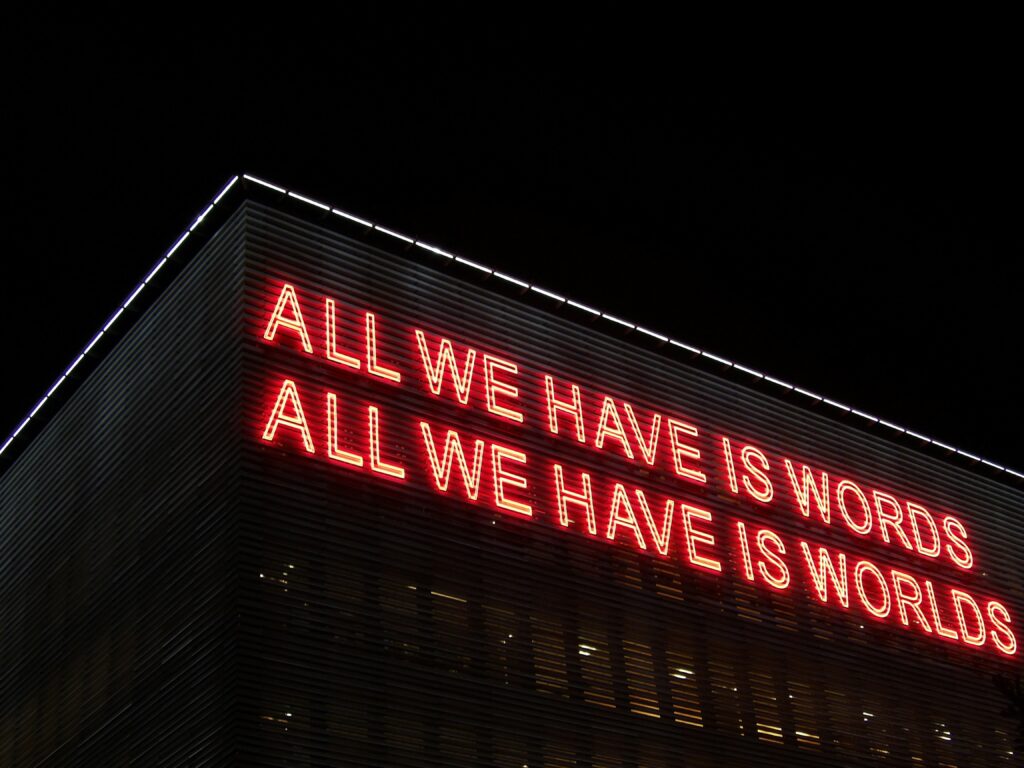Mentre crescono le violazioni (che avvengono “a norma di legge”) delle tutele nei confronti dei minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia, come riporta il Dossier Statistico Immigrazione 2024, un saggio (“Ragazzi sospesi”) fa luce su fenomeno complesso di questi arrivi, ne sottolinea le sfide gestionali e sociali principali ma ci mostra anche – attraverso l’esempio di Napoli – che si può fare di meglio e diversamente per accogliere e integrarare chi non è ancora maggiorenne e chi lo è appena diventato.
Non arrivano solo via mare. C’è il valico di Trieste, poi la rotta dall’Albania, da dove i ragazzi partono in pullman. Raramente senza alcun riferimento, più spesso tramite i contatti di altri nazionali già presenti nel territorio italiano. In alcuni casi si presentano direttamente sotto la direzione dei servizi sociali, che fanno quel che possono, in un contesto nazionale caotico e che segue politiche di gestione dei minori difficili tortuose. Come nel caso di Omar (nome di fantasia): è tra i minori salvati nel mare a sud della Sicilia da navi dell’ONG. Viene fatto sbarcare in Toscana, a Livorno, allungando tantissimo il percorso di viaggio e non prima di essere stato trattenuto in mare alcuni giorni, per poi essere caricato su un pullman e essere trasferito in un centro di accoglienza nel Meridione. Quella di Omar non è un caso immaginario: di Omar ce ne sono tanti. Ragazzi minori non accompagnati che, raggiunta l’Italia, sono trattati con “imbarazzante disumanità”, come ci spiegano Giovanna Tizzi e Elena de Filippo, curatrici, insieme a Glauco Iermano, del volume Ragazzi Sospesi. I neomaggiorenni stranieri verso l’autonomia (Franco Angeli editore) nell’intervista che ho raccolto assieme al collega Massimiliano Congiu.
«Naturalmente non dobbiamo dimenticare che quando si parla di politiche riguardanti i minori, questi ultimi devono essere collocati nelle strutture adeguate a loro, ovvero nelle diverse strutture che esistono per accoglierli. Purtroppo però – continua Giovanna Tizzi, che è formatrice e ricercatrice Oxfam Italia – sia con l’attuale governo sia in passato, a volte sembra esserci un atteggiamento di accanimento» (e di fatto, il governo Meloni non ha ancora recepito le richieste del Consiglio d’Europa di uniformarsi ai principi delineati da tre sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, con aumenti a norma di legge delle violazioni delle tutele nei confronti dei minori stranieri non accompagnati).
Il fenomeno dei ragazzi non o neo-maggiorenni che arrivano in Italia continua a essere trattato come un’emergenza. Eppure sappiamo che così non è. «Anche gli sbarchi di questi giovani – sottolinea Tizzi – rappresentano un fenomeno che dura da anni, dunque “incompatibile” con la gestione “emergenziale” del sistema di accoglienza.»
Gestione, tra l’altro che è va proprio a discapito di una progettualità, un investimento emotivo e sociale, nei confronti di questi ragazzi, «tutelati da una cospicua, complessa e spesso restrittiva legislazione sull’immigrazione, che interviene anche nella presa in carico del giovane in età minore, ma diventa centrale, in modo negativo e discriminante, una volta che il giovane ha raggiunto la maggiore età», spiega Glauco Iermano. Una volta raggiunta la maggiore età, questi migranti si trovano spesso a un bivio – restare in Italia o cercare fortuna altrove in Europa – ma, “abbandonati” a loro stessi, corrono il rischio di finire nelle maglie dell’illegalità, della criminalità, di traffici illeciti e della tratta umana. E anche per chi rimane nella legalità, le sfide sono numerose e complesse. « Insomma, al minorenne straniero viene garantito un completo e complesso sistema di tutela e protezione, ma quando raggiunge i 18 anni (“e un giorno”) perde la sua protezione per ritrovarsi improvvisamente catapultato nel mondo degli adulti e in un regime normativo restrittivo e discriminante. Ad esempio, uno dei problemi principali che affrontano questi giovani, una volta raggiunta la maggiore età, è trovare una casa – sottolinea Giovanna Tizzi – Molti riescono a trovare un lavoro stabile, ma l’affitto è spesso inaccessibile, sia nelle grandi città che nei piccoli centri. Questo rende difficile la loro integrazione e la costruzione di un futuro indipendente.»
Oltre alla mancanza di umanità, come sottolineato da Elena Tizzi, «c’è anche una miopia evidente: ignorare il potenziale di questi ragazzi e i benefici dell’inclusione per tutta la comunità è un controsenso. Dobbiamo guardare al futuro e investire in percorsi inclusivi. Sono ragazzi sospesi, le cui vite raccontano storie complesse e delicate: essi «meritano tutto il nostro impegno istituzionale e umano» enfatizza Elena de Filippo, che è anche Presidente di Daedalus, una cooperativa sociale che opera nel settore dell’immigrazione da oltre quattro decenni a Napoli: «i ragazzi sospesi vivono un momento di transizione che è decisivo: in questa fase, il giovane che non si sente solo ma accompagnato ha la possibilità di emanciparsi positivamente e, anche, di diventare una risorsa per sé stesso e per tutta la società d’accoglienza.»
«Negli anni ’90, con l’intensificarsi dei flussi migratori, soprattutto dal Maghreb e dal Marocco, e il conseguente invecchiamento della popolazione migrante, abbiamo assistito a un aumento significativo della presenza di minori non accompagnati. La risposta iniziale delle amministrazioni locali fu spesso repressiva, con l’immediato collocamento dei ragazzi in centri di accoglienza. Di fronte a questo approccio, abbiamo proposto un’alternativa innovativa: un centro a bassa soglia, dove i giovani potessero trovare un punto di riferimento senza essere costretti a interrompere il loro progetto migratorio. Questa scelta si è rivelata efficace nel creare un clima di fiducia e nel facilitare l’inserimento dei ragazzi nei percorsi di inclusione», spiega Glauco Iermano, Coordinatore Area Minori non accompagnati di Dedalus, che negli ultimi vent’anni e grazie alle oltre mille attività lavorative e percorsi di formazione e integrazione proposti, ha offerto ancore di salvezza migliaia di giovani (tra i 3mila e i 4mila ragazzi):
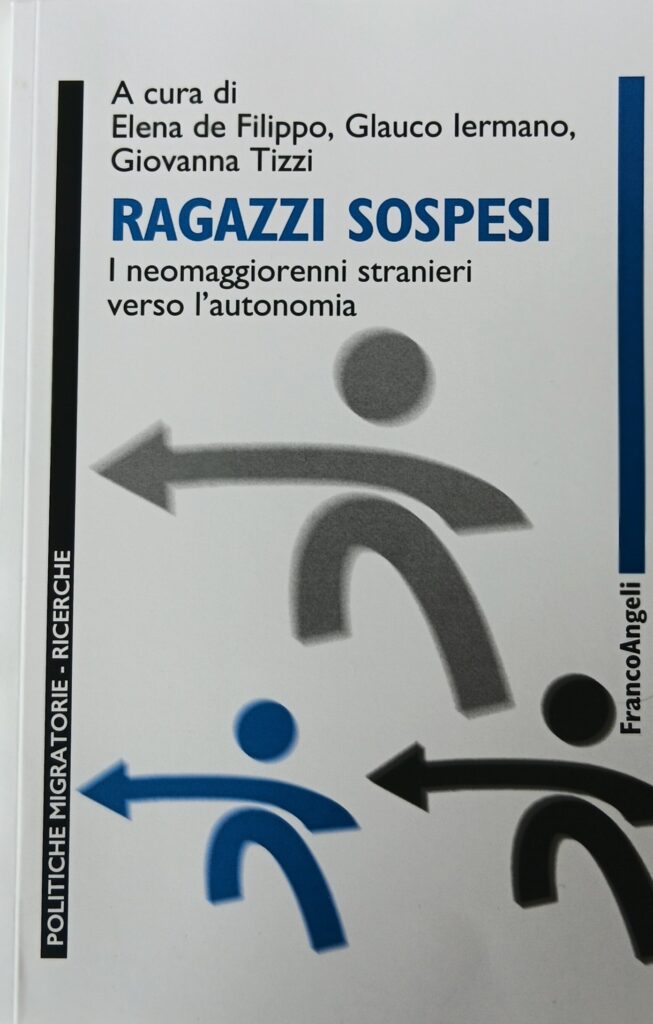
«Ecco che a 18 anni ho dovuto iniziare tutto da capo e da solo. Quando sono uscito dalla comunità vissuto nel paesino per altri sei mesi circa ma poi non riuscivo a sostenermi economicamente e così un giorno all’improvviso ho chiamato il ragazzo con cui vivevo e gli ho detto: “Mario stasera io parto per Napoli”. La sera stessa ho preso l’autobus e la mattina verso alle 7 sono arrivato alla stazione di Napoli, qui ho iniziato un nuovo percorso da zero, quando sono arrivato non sapevo a chi rivolgermi e così ho visto un ragazzo, gli ho chiesto se poteva aiutarmi a trovare una struttura per poter fare la domanda di asilo – racconta, in Ragazzi Sospesi, Couly da Mali giunto in Italia quando era ancora minorenne – […] Sarei finito sotto un ponte ma per fortuna dopo una settimana Lassaad, della cooperativa sociale Dedalus, mi ha chiamato per lavorare come interprete perché avevo una buona padronanza della lingua italiana: la mia fortuna inizia qui perché non solo ho trovato lavoro come interprete, ma la cooperativa Dedalus per agevolare il mio percorso di integrazione mi ha accolto in un progetto di autonomia guidata chiamato PAG […].»
Il “modello Napoli”, dove Dedalus, il Comune e altri attori del terzo settore lavorano congiuntamente per rispondere ai bisogni principali di minori e neo-maggiorenni stranieri non accompagnati (proprio a Napoli sono stati sperimentati i primissimi alloggi sociali per i neomaggiorenni), mette in luce la centralità di sinegie tra territorio, società, tra il luogo in cui viviamo e con le persone che lo abitano. «Purtroppo anche a Napoli, negli ultimi anni, sono cresciuti i pregiudizi nei confronti dei migranti e la strumentalizzazione del tema dell’immigrazione per fini elettorali. Di fronte a questa situazione – conclude Glauco Iermano – noi continuiamo a impegnarci concretamente per promuovere l’inclusione e per contrastare la disinformazione, cercando di offrire una narrazione alternativa basata sui fatti e che mette in luce come l’inclusione dei migranti non sia solo un atto di solidarietà, ma porti benefici a tutta la comunità. Quando includiamo le persone, promuoviamo lo sviluppo sociale ed economico del territorio.»