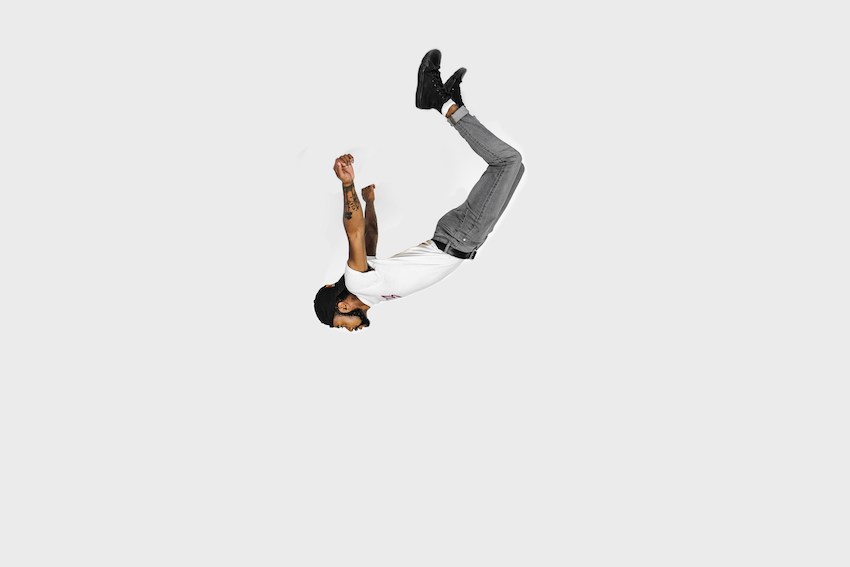Alcuni giorni fa è esplosa una bomba, una di quelle mine rimaste nascoste per anni e che poi qualcuno per puro caso calpesta.
Una donna, che preferisce restare anonima, vede una foto comparsa sulla sua pagina Facebook che ritrae il seno di un’altra donna in primo piano. Leggendo i commenti sotto l’immagine si insospettisce e visitando la pagina, dove era stata postata l’immagine, realizza in fretta che si tratta di un luogo in cui mariti, fidanzati e compagni condividono foto scattate in contesti domestici e intimi delle proprie mogli, fidanzate e compagne.
Dalla qualità delle immagini, spesso sfocate, con inquadrature storte e frettolose, emerge lampante la natura di queste condivisioni: sono foto prive del consenso dei soggetti ripresi ed in questo, ma ci torneremo più avanti, si scatena l’eccitazione del branco.
La donna denuncia la sua scoperta alla polizia postale e chiede a Carolina Capria, scrittrice e attivista, molto seguita sui social, di aiutarla a condividere la notizia per fare più luce sulla vicenda.
Il caso esplode in pochi giorni portando con sé una serie di interessanti conseguenze. Intanto si scopre che la pagina “Mia moglie” contava circa 32.000 iscritti, era aperta e accessibile a tutti ed era già stata segnalata in passato, ma vista la scarsa resa delle foto, non violava apparentemente i codici etici previsti dalla piattaforma.
Comincia a emergere un sottosuolo di decine di altri luoghi di condivisione simili su Facebook e Telegram, tutti caratterizzati dalla stessa tipologia di espressione: foto di corpi femminili dati in pasto al branco, al fine di definire e legittimare la propria mascolinità.
Perché qui risiede il potere che genera attrazione. Non sono le immagini di per sé ad eccitare queste migliaia di uomini, perché non si tratta di materiale pornografico, ma la convinzione che accomuna tutti gli utenti di poter disporre dell’immagine e quindi del corpo della propria compagna indipendentemente dal suo consenso.
Vi richiama per caso qualcosa? Una gravissima vicenda emersa in Francia un anno fa? Ebbene sì, il collegamento con il caso di Giselle Pelicot, sedata dal marito per anni per permettere a decine di uomini di abusare di lei mentre lui li filmava, è immediato. Un uomo, anzi in questo caso migliaia, che si eccitano a vicenda mostrando corpi che credono di possedere e di conseguenza di poterne disporre liberamente.
Un’altra conseguenza immediata (e prevedibile), poco dopo la diffusione della notizia, è stata la reazione difensiva che molti hanno ritenuto d’obbligo portare avanti per scagionare quei “ragazzacci” e la loro “bravata”. Uso volutamente l’aggettivo prevedibile perché questo non è altro che il sistemico meccanismo patriarcale di difesa, basato sul depotenziare la gravità della vicenda giustificandola come una cavolata su cui riderci sopra.
Questo aspetto rende ancora più palese la similarità con il caso Pelicot. Il fatto che mancasse totalmente il consenso per il 50% delle persone coinvolte non rappresenta un elemento sufficiente per determinarne la grave illegalità. Così come le testimonianze degli uomini imputati durante il processo Pelicot avevano rivelato una genuina ignoranza sulla questione del consenso o meno della vittima. Evidentemente a loro era bastato quello del marito per poter abusare di una donna semi incosciente.
La vicedirettrice della polizia postale Barbara Strappato ha dichiarato in un’intervista al Corriere: “Alcune donne si sono riconosciute e hanno sporto denuncia, molte altre sono ancora ignare di essere finite in questo squallido gruppo. Tutti i commenti finiranno nella nostra informativa, i reati vanno dalla diffamazione alla diffusione di materiale intimo senza consenso. Ammetto che mai prima di oggi ho visto frasi tanto disturbanti in un gruppo social, il nostro ufficio ha lavorato 24 ore per bloccare la pagina, abbiamo ricevuto in poche ore più di mille segnalazioni, quello che è accaduto è molto grave, è stato difficile anche per me leggere tutti quei commenti.”
Altri hanno tentato la strada della negazione: le donne coinvolte erano consenzienti. A questo proposito Carolina Capria ha scritto: “Chi dice che quelle foto fossero fatte con il consenso della persona ritratta semplicemente non le ha viste. O ci troviamo davanti a degli artisti della messa in scena, capaci di riprodurre il disordine, la sciatteria tipica di posizioni non studiate, di inquadrature di fortuna, o quelle foto erano esattamente quello che sembravano: scatti rubati in situazioni di intimità. La polizia postale lo conferma, le donne che si sono ritrovate lo confermano, eppure si nega l’evidenza. Del resto se non vivessimo in una società che nega l’evidenza di un sistema di sopraffazione che ha radici culturali, quella pagina nemmeno sarebbe esistita.”
E, aggiungo io, se neppure le vittime di stupro vengono credute e spesso si ritrovano a dover subire interrogatori avvilenti solo per poter dimostrare la veridicità dei fatti, (dissuadendo di conseguenza molte altre donne dallo sporgere denuncia), come possiamo stupirci ancora di fronte allo scudo di negazione e ilarità che immediatamente si alza a difendere i colpevoli di fronte a fatti tanto palesi e già convalidati?
Di questo caso hanno parlato da subito anche i media esteri perché le persone coinvolte sono tante, soprattutto le migliaia di vittime ancora ignare di essere state merce di scambio per eccitazioni sessuali di gruppo. Ma credo soprattutto per il fatto di aver potuto agire liberamente su piattaforme pubbliche, per chissà quanti anni, senza nessuna forma di censura o impedimento.
Perché questa singola vicenda emersa in realtà è soltanto la punta di un iceberg ben più grande, composto da altri centinai di luoghi in rete dove gli uomini condividono materiale intimo senza il consenso delle persone coinvolte. Emerge, come scrive ancora Carolina Capria,“ la mancanza di tutele e di un sistema che funziona.”
“Trattandosi di un problema sistemico”, continua Capria, “la soluzione definitiva non passa dalla punizione di un comportamento ma da un mutamento della struttura di pensiero: le donne rappresentano da sempre il terreno sul quale gli uomini si sfidano e misurano la loro virilità. Mostrare a un altro uomo la “propria” donna come un bene che si può concedere ma comunque si possiede, significa stabilire una gerarchia. È un gioco nel quale le donne sono solo una merce, un bene che aggiunge valore all’uomo che la possiede.”
Dove risiede quindi la soluzione, o meglio il complicatissimo lavoro da cui partire: demolire e riformulare il modello stesso di mascolinità, a partire da un’educazione, una cultura, una società in grado di prendere distanze nette dal sistema patriarcale che continua a definire e influenzare qualunque contesto, qualunque ripeto, e abbracciare nuovi valori e modelli.
Un processo complesso, lungo e trasformativo che alcune società già possiedono, per tradizione culturale o perché sono state più brave a coglierne l’urgenza, altre come la nostra lo stanno appena intraprendendo, attraverso il lavoro instancabile di attiviste e divulgatrici, ma anche insegnanti, artiste e professioniste che lavorano proprio partendo dal basso dei loro contesti, a immaginare insieme una società nuova dove questi “mercati di scambio dei corpi femminili” perdano qualunque possibilità di diffusione libera e impunita.