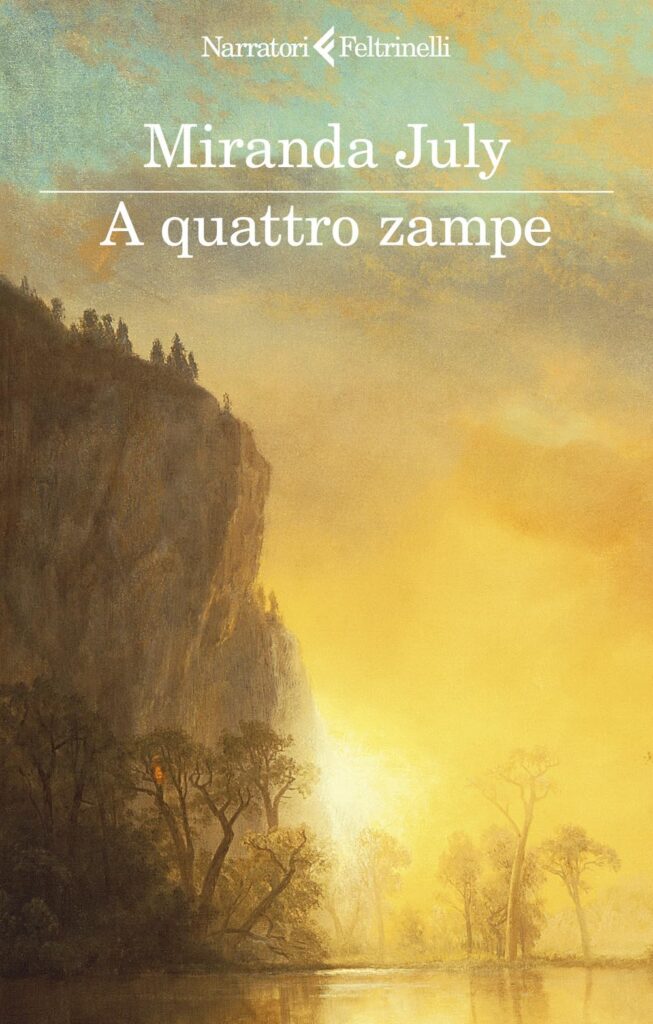Noi siamo le parole che usiamo, tanto più se disponiamo di un ruolo di rappresentanza e gli effetti del nostro linguaggio possono influenzare masse e pensieri.
Il linguaggio ha sempre una valenza politica, prima ancora che culturale, perché può venire strumentalizzato per definire i valori di una società e può risultare molto rischioso se manca nelle persone la consapevolezza di questo fenomeno.
In un mio precedente articolo ho provato a spiegare come la nostra Presidente, Giorgia Meloni, faccia uso del gender washing per far passare un messaggio errato sul suo reale interesse alle cause di discriminazione e disparità di genere. Tesi peraltro che ha trovato piena dimostrazione nella sua scelta insindacabile del titolo con il quale vuole essere chiamata: Signor Presidente del Consiglio.
C’è, dietro a questa scelta linguistica, una forte consapevolezza politica, dettata dal bisogno di assecondare una fascia di elettori, quelli che l’hanno votata, caratterizzati da una linea di pensiero tradizionalista e patriarcale, in cui “l’appropriazione lessicale femminile” di cariche istituzionali, da sempre nominate esclusivamente al maschile, non è contemplata.
Nonostante il cambiamento sia ormai avviato e riconosciuto da qualunque istituzione linguistica preposta a definirne l’oggettiva correttezza grammaticale, indipendentemente da quella etica, Giorgia Meloni sceglie di restare ancorata a un’immagine che la riconosce come donna solo nel contesto famigliare e religioso. Quante volte l’abbiamo sentita dire: -Sono madre e sono cristiana.-
Il suo ruolo istituzionale invece rimane maschile, come se glielo avessero momentaneamente affidato in qualità di matrona, posta a risanare l’ordine e l’equilibrio della grande famiglia italiana, ma che non le apparterrà mai, perché il potere resta maschile e neppure lei può (o meglio, vuole) farci nulla.
Ma proseguiamo nell’analizzare “la riforma linguistica” che è stata effettuata su alcuni ministeri del Governo Meloni.
Al Ministero dell’Agricoltura è stato aggiunto “e della sovranità alimentare”. Questo concetto non è nuovo, ma è stato coniato dalla Via Campesina nel 1996 come manifesto della de-globalizzazione dei sistemi alimentari. Si basa, come sostiene Slow Food, sul diritto di ogni Paese di stabilire le proprie politiche alimentari, le modalità di produzione e distribuzione, con l’intento di garantire a tutti un cibo sano e sostenibile. Il problema si pone nel momento in cui si utilizza la parola sovranità in un contesto politico già evidentemente xenofobo e nazionalista. Che cosa porterà nello specifico la possibilità di scegliere chi tutelare o favorire nel contesto produttivo nazionale e nel commercio internazionale? Staremo a vedere.
È certo che la parola “sovranità” ha un grande peso di responsabilità. L’inclinazione dell’asticella tra la lotta al caporalato, garantendo controlli e condizioni di lavoro più sicuri nel campo dell’agricoltura italiana e dall’altra parte la dichiarata lotta aperta di Salvini contro la carne sintetica, nonostante gli evidenti vantaggi ecologici ed etici che scelte di produzione alternative permetterebbero, è molto labile.
Molto meno dubbia risulta invece la scelta di aggiungere al Ministero dell’istruzione la parola merito. Può esistere un ossimoro più riuscito? Il concetto di istruzione si basa su un’idea democratica di apprendimento in cui tutti, indipendentemente dalla propria situazione socio-economica e con i propri tempi, possono apprendere, scoprendo i propri talenti e fiorire. Il merito si basa su un concetto standardizzato di obiettivi da raggiungere, obiettivi che nel nostro particolare contesto storico e sociale puntano a creare individui in grado di produrre rapidamente, sempre performativi, sicuri e molto ambiziosi. Cosa significa meritare? Significa aver risposto a richieste ed esigenze precise, e chi può farlo? Chi parte già in condizioni favorevoli. La meritocrazia innesca dinamiche di classismo e selettività. Tutto l’opposto di ciò che la scuola si propone di fare. Offrire a tutti, nessuno escluso, la possibilità di imparare, rispettando le unicità e le condizioni di partenza di ognuno.
Chiudiamo in bellezza con il Ministero della famiglia, natalità e pari opportunità. Già la scelta della ministra Eugenia Roccella, anti abortista, portavoce del Family Day, apertamente contraria alle unioni civili e ai diritti per la comunità Lgbt+, rappresenta la presa di posizione politica più chiara di questo Governo. È evidente che mettere insieme la parola famiglia, natalità e pari opportunità significa evidenziare l’attenzione verso i cittadini di serie A: etero, sposati e genitori, rispetto ai cittadini di serie B, ossia tutti gli altri, che sono tantissimi, che non rientreranno nel piano di tutele pensate e promosse. Anche qui ci troviamo di fronte a un doppio ossimoro perché prima definiscono con i termini famiglia e natalità quali siano le priorità del ministero, per poi aggiungere quel “pari opportunità” snaturando e strumentalizzando un concetto che per sua natura dovrebbe essere solamente inclusivo.
Insomma abbiamo capito quanto il linguaggio possa definire intenti e valori. È da sempre il primo campanello d’allarme per intercettare cambiamenti o fragorose ricadute. Non abbassiamo mai la guarda sulle parole, anche quelle che prese singolarmente sembrano innocue, poco potenti, a volte persino ridicole.
Le parole ci definiscono prima ancora delle nostre azioni. Sono armi politiche potenti e chi oggi è stato messo da noi a governare sa bene come e dove usarle.