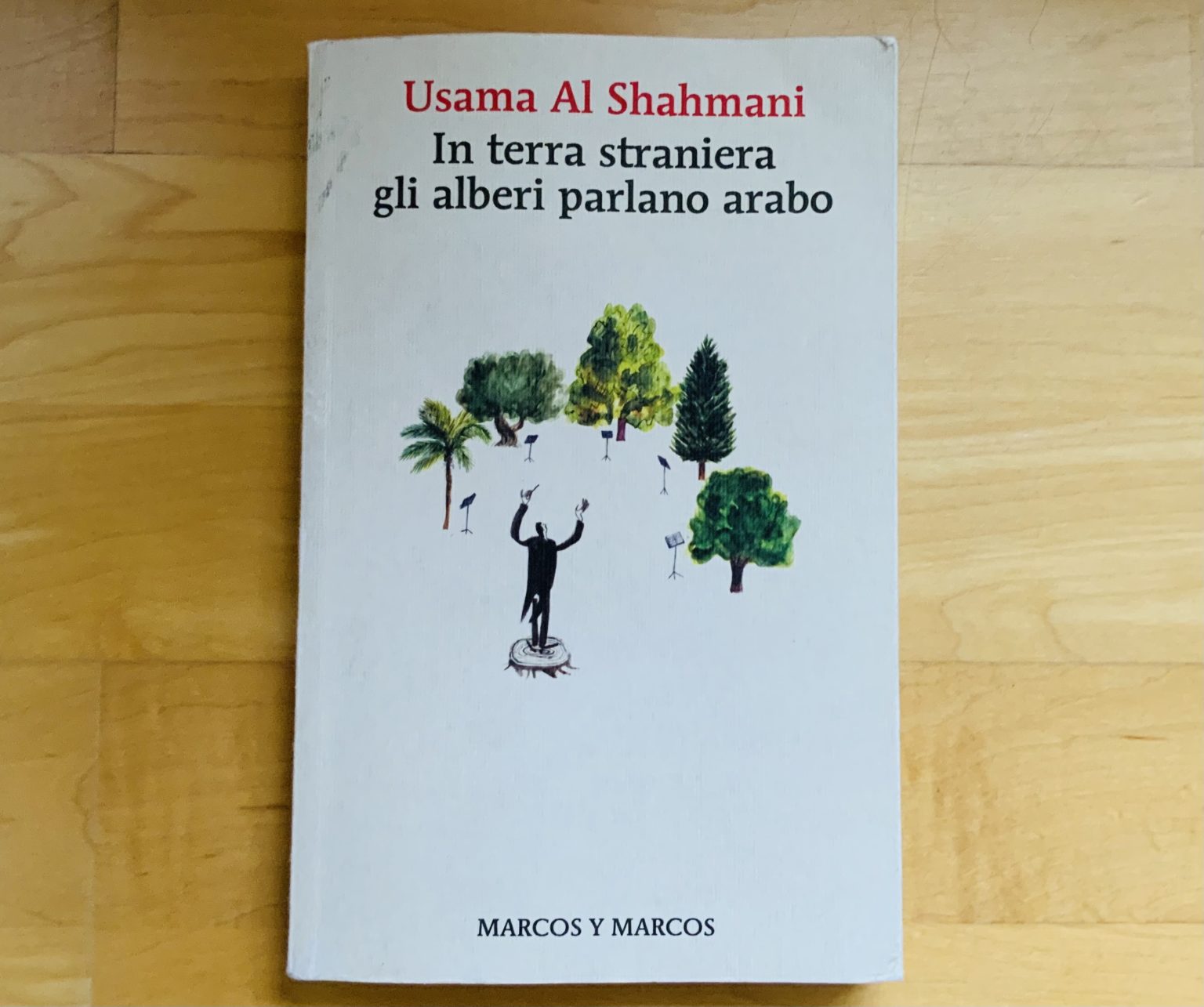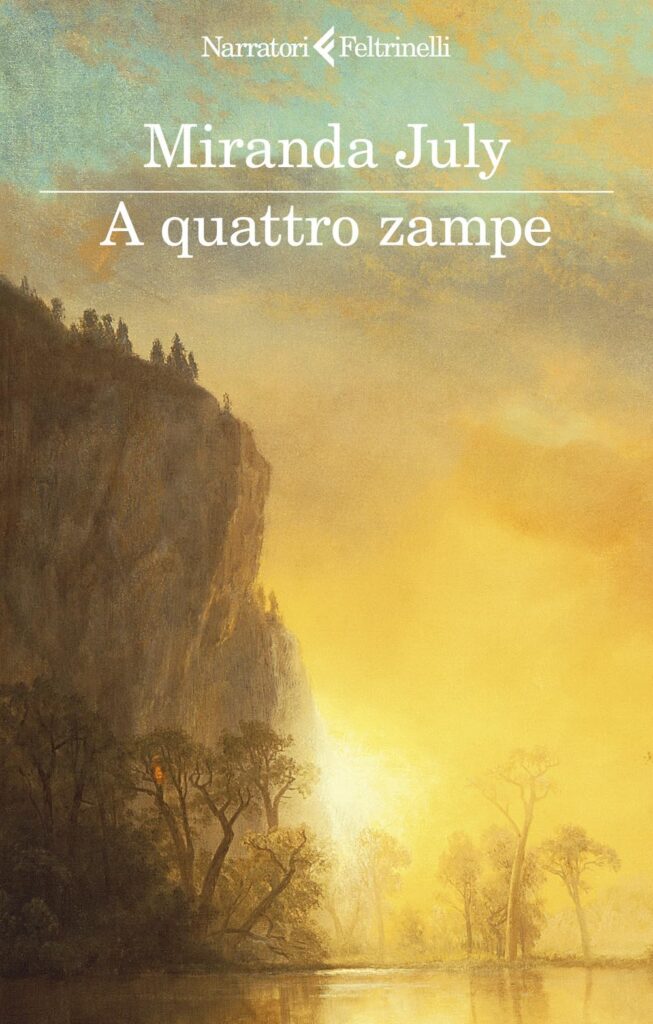“Il bosco è e rimane l’unico laboratorio in cui i miei esperimenti riescono bene.Spargo le lettere, le parole, la lingua sulle foglie e tra i rami. Nel bosco riesco ad appartenere a me stesso. Il bosco è l’unico tempio in cui mi sento più leggero, avverto che la mia anima si purifica e il mio cuore si rinnova”.
Quante volte abbiamo sentito la necessità di isolarci nella natura: prendere un sentiero nel bosco, salire verso una vetta o camminare scalzi su una spiaggia deserta. Serve ritrovare quel silenzio, che non è un reale silenzio, ma mette a tacere i pensieri più ossessivi, rallenta i palpiti e spolvera via ogni urgenza. Sentiamo tornare una presenza attenta e concentrata sul semplice gesto di guardare e ascoltare tutto ciò che non è umano e che per una misteriosa alchimia ci guarisce.
Questo è ciò che ci racconta Usama Al Shahmani, iracheno residente in Svizzera da molti anni, nel suo romanzo autobiografico In terra straniera gli alberi parlano arabo, edito in Italia da Marcos Y Marcos editore.
La sua storia emerge lentamente con flash back che dalla sua quotidianità nel campo per rifugiati ci riporta indietro a rivivere con lui il clima di terrore e l’assoluta incertezza che dilagava nella sua città Bagdad, con le conseguenze della guerra del Golfo e sotto il regime di Saddam.
La dolorosa e necessaria ricostruzione del suo passato viene innescata dalla tragica notizia della scomparsa di suo fratello più giovane Ali. Le ricerche da parte della famiglia sono dilanianti e inutili. Scopriamo che esistevano luoghi di raccolta dei corpi non identificati che venivano mostrati ai parenti attraverso foto o video raccapriccianti, che rivelavano drammaticamente, attraverso i segni della tortura e le mutilazioni, gli ultimi giorni di vita di quei figli, mariti e padri scomparsi. Scopriamo ancora un mondo sotterraneo di truffe e azioni illegali, che si alimentava delle speranze e dei soldi di famiglie senza più nulla se non la speranza di ritrovare un corpo da seppellire.
Usama Al Shahmani ha vissuto la scomparsa del fratello come una doppia impotenza; la lontananza dal suo paese d’origine, le limitate informazioni che riceveva dai suoi fratelli e dai genitori lo hanno tormentato nell’ incapacità di poter trovare una soluzione o anche semplicemente portare conforto fisico ai suoi cari.
Aveva bisogno di raccontare la sua storia, sentire l’arabo uscire dalla sua bocca e trovare chi potesse semplicemente accogliere il suo dolore. Nel bosco ha trovato la pace che cercava.
“Fu una bella sensazione, sentire l’arabo nel bosco. Dunque la natura non era affatto muta, bastava rivolgerle la parola e stare ad ascoltarla.”
Le prime pagine del libro ci raccontano un fatto interessante: il concetto di “camminare” nella natura, per il puro piacere di farlo è stato appreso dal giovane iracheno per la prima volta in Svizzera, tramite la zia di un compagno del centro di accoglienza, giunta già quarant’anni prima e sposata con uno svizzero. Fa fatica a definirla persino irachena tanta è la diffidenza iniziale che Usama prova verso la donna, che usa parole e attitudini che non hanno niente a che vedere con la loro comune cultura di origine.
Si cammina per andare da qualche parte, crede fermamente Usama, al massimo come pellegrinaggio verso la Mecca. Gli iracheni non camminano per il gusto di camminare, tanto meno dentro i boschi.
Da questa incomprensione linguistica comincia la lenta integrazione del ragazzo, con le difficoltà nel trovare un lavoro a lungo termine a causa del suo visto da rifugiato e lo studio del tedesco con l’ulteriore complicazione nel comprendere il dialetto svizzero. Col tempo qualcosa comincia ad aprirsi in lui. Osserva il paesaggio che lo circonda, così diverso da quello dell’Iraq e accetta di avvicinarsi e provare a conoscerlo. Avviene la svolta. Sente tra gli alberi una presenza viva che lo rassicura e attraverso la vegetazione autoctona si riavvicina anche ai suoi ricordi, proprio attraverso gli alberi che hanno avuto una funzione determinante nella sua vita.
“Quando dico patria il mio occhio interiore vede una palma da datteri” scrive all’inizio di un capitolo ed è proprio quella stessa pianta, molto più piccola e dentro un vaso, che decide di far crescere nella sua nuova patria, salutandola in arabo ogni mattina.
È un romanzo poetico e fluido, capace di raccontare la guerra attraverso lo sguardo di un civile in tutta la sua insulsa spietatezza e imparzialità. Chiunque in Iraq ha temuto per la propria vita, ribelli o persone qualunque, bambini o donne di ritorno dalla spesa, nessuno si sentiva al sicuro e questo senso di precarietà arriva forte come un disagio tra le righe di Usama Al Shahmani.
Ma il pregio maggiore di questo autore sta nella capacità di spingersi oltre il dramma di una popolazione e attraverso la speranza di un singolo far passare un importante messaggio di rinascita. C’è una frase del libro che continua a risuonarmi nella mente:
“In ogni caso, il mio talento per la vita è e rimane l’essere felice”.
Detto da chi ha attraversato l’inferno, rischiato di morire,lasciato la sua patria e perso un fratello, rivela l’incorruttibile spinta vitale di quest’uomo e non mi stupisce se proprio negli alberi ha trovato quella stessa capacità di adattamento e trasformazione che gli hanno permesso di raccontare la sua storia in una lingua non sua, mantenendo la stessa forza di intenti e di poesia.