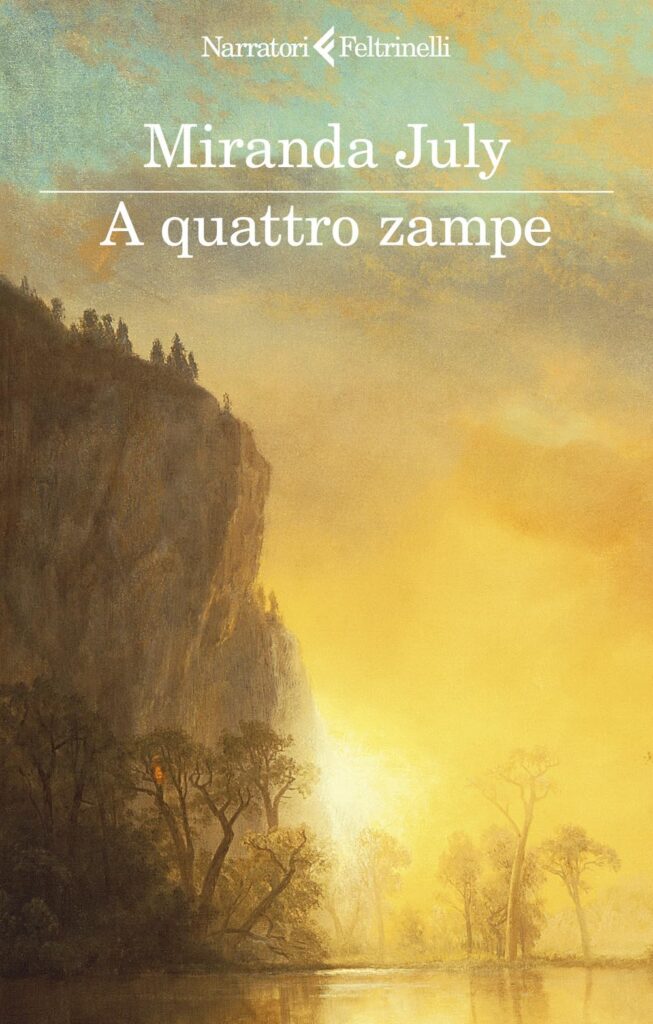di Valeria Camia e Alessandro Vaccari
La terribile alluvione che ha colpito in particolare la regione di Valencia ripropone il tema del rapporto tra eventi di questa natura e riscaldamento climatico. Pochi giorni fa, proprio a un mese dall’alluvione, abbiamo cercato di capire insieme cosa è successo a Valencia da un punto di vista meteorologico e se si può ipotizzare che la particolare virulenza di un fenomeno già verificato in questa regione in altre circostanze sia in qualche modo riconducibile al riscaldamento climatico. Si può ipotizzare in generale che il riscaldamento globale provochi o almeno aggravi molti di questi fenomeni e cosa si può concretamente fare per prevenirli o almeno attenuarli? Ne abbiamo parlato con Lorenzo Pasqualini, giornalista, geologo, fondatore del sito Italo-Spagnolo El Itagnol, capo redattore del sito Meteored Italia.
L’intervista integrale la potete ascoltare cliccando su questo link https://www.spreaker.com/episode/un-mese-fa-l-alluvione-in-spagna-cosa-e-successo-e-cosa-ci-aspetta-intervista-con-lorenzo-paqualini-geologo–63064295
—- —- —-
Qui invece un estratto di quanto Pasqualini ci ha spiegato sul fenomeno meteorologico estremo provocato da quello che viene definito con l’acronimo spagnolo DANA e che si può tradurre in italiano come “depressione isolata ad alta quota”.
«Il termine goccia fredda – inizia col chiarire Pasqualini – è esattamente la stessa cosa della DANA. Come dice il termine, è sostanzialmente una zona negli alti livelli, quindi parliamo di quote piuttosto alte, a migliaia di metri dalla superficie, dove si creano dei nuclei di aria fredda che si staccano dalla circolazione generale, cioè dalla corrente a getto, e che quando transitano, specialmente nell’area del Mediterraneo, alla fine dell’estate o in autunno, in determinate condizioni possono generare condizioni di maltempo molto forti. In altre parole la DANA è una goccia fredda, quindi è un fenomeno meteo nel quale questa presenza di aria fredda in quota, specie se arriva in un contesto di aria ancora calda perché è finita da poco l’estate o perché ormai siamo in una stagione autunnale caldissima, a causa del contrasto fra freddo e caldo, oltre all’umidità che arriva dal Mediterraneo, causa dei fenomeni meteorologici molto violenti.»
A partire dal fatto che eventi meteorologici di questo tipo creino o meno gravi perturbazioni, e in questa regione non sono fenomeni nuovi, quello che ci chiediamo è se, data la situazione di riscaldamento climatico, la particolare virulenza di questo fenomeno non sia in qualche modo collegata con il riscaldamento globale e in particolare con il modo in cui questo fenomeno interessa l’area mediterranea.
«A questo riguardo ho partecipato lunedì a un interessante dibattito fra meteorologi e climatologi presso la sede di MeteoRED, una delle principali imprese di meteorologia in Spagna, che è presente anche in Italia e per la quale ho il piacere di lavorare; questa conferenza si è svolta proprio a un mese dalla catastrofe nelle sedi di MeteoRED che si trovano nella regione di Murcia, nel sud. È stato molto interessante – dice Pasqualini – perché i meteorologi e climatologi ovviamente dalla loro prospettiva scientifica sono sempre cauti nell’analizzare questi fenomeni e non li attribuiscono automaticamente al cambiamento climatico, però sappiamo che il cambiamento climatico, un aumento delle temperature globali che sta avvenendo in maniera molto rapida, sta facendo sì che aumentino i fenomeni di maltempo estremo come questo, quindi aumentano in percentuale e in quantità. Un’altra cosa interessante che è emersa da questo dibattito è che i meteorologi non nascondevano assolutamente la loro totale sorpresa davanti a un fenomeno che è stato particolarmente virulento e che, lo ricordiamo, non ha colpito solo Valencia. I meteorologi sono molto stupiti dal fatto che questi temporali abbiano avuto la capacità addirittura di creare alluvioni lampo in zone dove prima non avvenivano. Questi fenomeni stanno diventando più potenti e più frequenti, dunque con tutte le cautele del caso, possiamo dire che tutti i segnali che arrivano dal mondo, non solo dalla Spagna, ci stanno parlando di qualcosa che sta cambiando molto rapidamente.
Un altro dato che forse andrebbe sottolineato e che i meteorologi hanno confermato anche in questa conferenza a cui ho assistito, è che un motore fenomenale che alimenta questi fenomeni meteorologici violenti è il calore dei mari. Il problema è che il mare Mediterraneo si sta scaldando in maniera ancora più rapida rispetto agli oceani. lnsomma, questa catastrofe che ha colpito Valencia è stata così forte proprio perché questo temporale gigantesco che si è creato trovava alle sue spalle, alla fine di ottobre – quindi comunque già in autunno inoltrato – un mare Mediterraneo ancora caldissimo, troppo caldo per la stagione. Questa situazione faceva sì che dal punto di vista fisico ci fosse tantissimo “carburante” per il temporale.»
Come continua a spiegarci Pasqualini, l’evento alluvionale di Valencia ha evidenziato gravi carenze nella comunicazione e nella gestione delle emergenze. Anzitutto, e nonostante le autorità avessero diramato un’allerta rossa, segnalando un rischio elevato per la vita umana, la popolazione ha continuato le proprie attività quotidiane come se nulla fosse. Scuole, negozi e uffici sono rimasti aperti, dimostrando una scarsa percezione del pericolo. L’allerta rossa, sebbene importante, non è sufficiente a raggiungere tutti i cittadini – e questo suggerisce tra l’altro quanto sia necessario un sistema di comunicazione più diretto e capillare, come i messaggi di allerta sui telefoni cellulari (IT Alert in Italia, ES Alert in Spagna). Infine un altro elemento mancante è stato l’allarme idrologico. Le alluvioni a Valencia sono state causate da piogge torrenziali a monte, che hanno provocato una piena improvvisa. Un sistema di allerta idrologica avrebbe potuto avvisare la popolazione del rischio di inondazioni anche in zone dove non pioveva direttamente.
A fronte di tutti ciò, e chiedendoci che cosa si possa fare per evitare che si ripetano simili tragedie, l’esperto punta il dito verso l’importanza di rendere più efficace e capillare il sistema di allerta, utilizzando tutti gli strumenti disponibili, inclusi i messaggi diretti sui telefoni cellulari. Altro aspetto centrale è aumentare la consapevolezza dei rischi legati ai fenomeni meteorologici estremi e insegnare alla popolazione come comportarsi in caso di emergenza, così come investire in tecnologie per il monitoraggio delle condizioni meteorologiche e idrologiche, in modo da poter prevedere con maggiore precisione gli eventi estremi.
E che dire della questione cementificazione? «Nella prevenzione ci metto dentro anche tutto il discorso della cementificazione del territorio, che in questo caso purtroppo torna ad essere evidente, nel senso che tantissime aree edificate si trovano in zone a rischio inondazione – spiega Pasqualini – Si tratta di un problema che abbiamo anche in Italia, nel senso che ci sono zone a rischio inondazione “a 500 anni”, che è un termine che trae un po’ in inganno, perché uno pensa che nei prossimi 500 anni non ci saranno situazioni catastrofiche; in realtà è un termine probabilistico che ci dice che nei prossimi 500 anni c’è una probabilità che succeda. Peraltro queste sono tutte percentuali che andranno riviste con il cambiamento climatico, insomma sono tutti aspetti che andranno tenuti in conto, sia la preallerta, quindi sostanzialmente mettersi in salvo, sia anche il fatto di come usiamo il territorio, troppo cementificato. Bisogna sicuramente creare delle casse di espansione lungo i fiumi per fare in modo che l’acqua quando ci sono delle piene vada ad inondare delle zone dove non crea danni; un’altra cosa ancora da considerare è l’abbandono delle campagne e delle montagne, perché comunque si creano queste enormi piene anche perché in montagna non c’è più chi coltiva, i suoli sono molto compattati e quindi quando piovono queste enormi quantità di acqua, se le terre fossero coltivate, una parte almeno di acqua si infiltrerebbe nel terreno e sarebbero ridotti i danni della piena.»
Ricordiamo poi il fatto che, seppur riuscissimo a rispettare l’Accordo di Parigi e limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5°C entro il 2100, gli effetti del riscaldamento globale sarebbero comunque visibili a causa delle emissioni passate. Risulta – a nostri occhi – dunque chiaro come sia fondamentale che le società si adattino a un clima che cambia, soprattutto nelle regioni mediterranee come Italia e Spagna, e come l’aumento delle temperature e dei fenomeni meteorologici estremi richieda misure di adattamento urgenti. Insomma, il riscaldamento globale è una realtà e le sue conseguenze sono già visibili. È necessario agire su vari fronti: certamente ridurre le emissioni di gas serra a lungo termine e allo stesso tempo adattare le nostre società ai cambiamenti climatici nel breve termine. La prevenzione, la preparazione e la comunicazione sono fondamentali per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici.