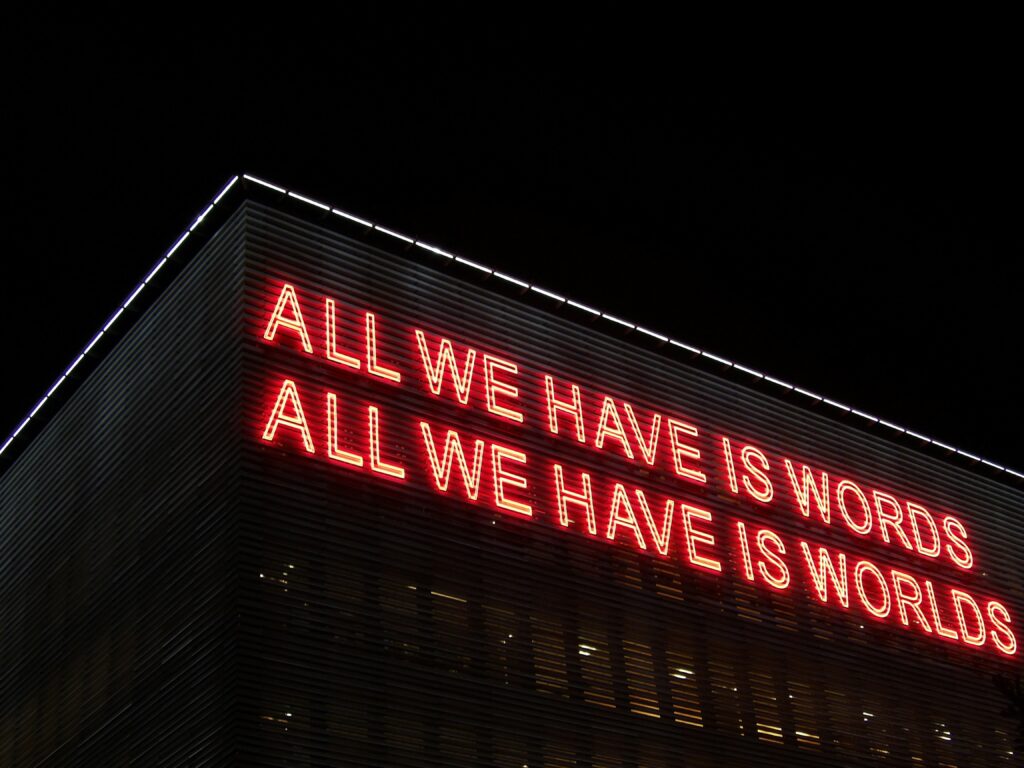Di Valeria Camia e Alessandro Vaccari
Nel podcast di oggi ci concentriamo sul caso Miteni e in particolare parliamo delle Mamme No Pfas. Sapete chi sono? Ce ne hanno parlano il professor Adriano Zamperini e la professoressa Marialuisa Menegatto, entrambi dell’Università di Padova, autori di un articolo scientifico pubblicato sulla rivista Social Sciences (2024, 13) dal titolo Contamination of Perfluoroalkyl Substances and Environmental Fight for Safe and Health: The MammeNoPfas Movement as Epistemic Community. Lo studio ha dimostrato che le competenze acquisite dalle MammeNoPfas hanno permesso una partecipazione significativa alle questioni ambientali e sanitarie.
Ma prima un ripassino: PFAS, acronimo difficile da pronunciare, sta per sostanze polifluoroalchiliche, create dall’uomo, chimicamente, apprezzate per le loro proprietà di resistenza all’acqua, al grasso e alle macchie. Queste sostanze, una volta immesse nell’ambiente dalle aziende, ci rimangono. Per questo anche note come “sostanze chimiche eterne”.
Il problema è che i PFAS sono tanto resistenti quanto pericolosi, come si è scoperto negli anni, anche se continiamo a circondarci di loro! I PFAS possono inquinare le falde acquifere e quindi arrivare nell’acqua usata per irrigare i campi agricoli oppure per dissetare gli animali o ancora nell’acqua che arriva nei nostri rubinetti. Possiamo davvero vedere i PFAS nel nostro sangue (basta un prelievo mirato) – e anche se smettessimo di ingerire queste sostanze per un certo tempo e il nostro sangue non le rilevasse più, non è chiaro quale e quanto sia il loro effetto sugli organi interni. Anzi, la comunità scientifica è sempre più convinta, sulla base di evidenze, che esista un legame tra PFAS e una serie di malattie e problematiche di salute, da tumori, problemi alla tiroide, infertilità, per fare qualche esempio.
Nel 2020 l’EFSA, Autorità europea per la sicurezza alimentare, ha stabilto una nuova soglia di sicurezza per i PFAS negli alimenti. La dose settimanale tollerabile è fissata a 4,4 nanogrammi per chilogrammo di peso corporeo alla settimana. e nel 2023 l’EFSA e diversi Stati membri hanno creato un “Gruppo di iniziativa sui PFAS” con l’obiettivo di condividere informazioni e costruire approcci collaborativi nel campo della valutazione dei rischi da PFAS.
In Europa sono diverse le zone ad alto tasso di PFAS. Anche in Italia, la questione dei PFAS è seria, soprattutto in alcune aree industrializzate e tra queste il Veneto. E’ coinvolta la società Miteni che ha prodotto per 50 anni impermeabilizzanti liquidi, noti appunto come Pfas, causando danni per 136 milioni di euro, coinvolgendo circa 350 mila cittadini nelle province di Vicenza, Verona e Padova – un’area di almeno 700 chilometri quadrati. Dai dati sanitari sinora raccolti emerge un elevato tasso di mortalità legato all’esposizione ai PFAS. Tra il 2007 e il 2014 per esempio è stato riscontrato un eccesso di decessi per malattie cerebrovascolari, diabete mellito, cardiopatia ischemica e demenza, ipertensione arteriosa e malattie tiroidee. Mentre per gli ex lavoratori Miteni è stato accertato un tasso di mortalità più alto del 45% rispetto alla media regionale.
Questa che ascolterete è il racconto della lotta delle mamme No PFAS in Veneto, la loro presa di coscienza del problema e il loro percorso di acquisizione di informazioni scientifiche che le ha portate a diventare referenti e “autorità” riconosciute sulla questione di una dei più grandi disastri ambientali in Italia e non solo.
Un po’ di cronologia sulla lotta delle mamme No PFAS
Nel 2013 la Regione Veneto ricevette dal Ministero dell’Ambiente l’esito di uno studio del Cnr che rilevava una presenza “preoccupante” di PFAS nelle acque potabili di alcuni comuni veneti. Nel giugno dello stesso anno, su sollecitazione dell’Istituto Superiore di Sanità che pure non ravvisava “un rischio immediato per la popolazione esposta”, la Regione introdusse una serie di prelievi e di interventi sugli acquedotti per mitigare il fenomeno.
Nel marzo 2017 iniziarono a circolare i primi risultati di uno screening effettuato sui giovani fra 14 e 29 anni in alcuni Comuni interessati dal fenomeno che faceva emergere risultati inquietanti con valori di presenza nel sangue di sostanze PFAS fino a 40 volte superiori a quello di popolazioni non esposte.
A questo punto 4 mamme presero l’iniziativa sollevando il problema in tutti gli ambiti delle loro relazioni sociali e in pochi giorni la presa di coscienza da parte di centinaia di donne portò alla creazione del Gruppo Mamme No PFAS.
Nel maggio del 2017, nel corso di una riunione molto accesa e partecipata, le mamme vennero a conoscenza dei dati dettagliati delle ricerche sulla presenza dei PFAS nella zona che evidenziavano responsabilità degli autori di veri e propri ecoreati, nonché il silenzio delle Autorità competenti che tacevano, avallando di fatto questa situazione. La serata rappresentò una svolta nella consapevolezza e nella rabbia delle donne che da allora cominciarono a sollecitare in modo sempre più pressante efficaci interventi e la fine dell’omertà su questo delitto ambientale e sulle sue conseguenze.
La zona particolarmente interessata al fenomeno abbraccia una superficie di circa 180 chilometri quadrati nelle provincie di Vicenza, Verona e Padova in cui vivono circa trecentocinquantamila persone.
Da allora è stato un susseguirsi di iniziative sempre più incisive e partecipate che, oltre a coinvolgere in modo sempre più ampio le popolazioni delle zone colpite, hanno indotto le autorità civili e a intervenire in particolare sul problema dell’acqua potabile. Anche rappresentanti del clero cominciarono a solidarizzare con le iniziative delle donne e lo stesso papa Francesco non ha mancato in questi anni di far sentire il suo appoggio. Non è mancata la proiezione a livello internazionale della protesta, con la richiesta di intervento da parte del Parlamento europeo e l’invito in Italia all’avvocato statunitense Robert Billot che aveva guidato una lotta vincente nel proprio Paese contro la stessa forma di contaminazione, provocato dal gruppo DuPont. Nel settembre del 2017 la regione Veneto decise di abbassare i limiti tollerati di Pfas nell’acqua potabile. La società Miteni fu individuata come una delle massime responsabili dell’inquinamento e venne accusata in particolare di aver sversato nell’acqua potabile di falda e superficiale sostanze inquinanti appartenenti al gruppo dei tensioattivi perfluorilati.
Nell’agosto del 2018 le mamme No PFAS organizzarono un presidio davanti alla Procura di Vicenza per sollecitare l’incriminazione dei dirigenti responsabili della Miteni e per richiedere un risarcimento danni.
Nel 2021 è effettivamente iniziato il processo contro la Miteni che però in precedenza aveva presentato la procedura di fallimento, con il rischio di far ricadere sulla collettività i costi dei risarcimenti. Il processo dovrebbe concludersi all’inizio dell’anno prossimo con la speranza di evitare il pericolo della prescrizione; la vigilanza delle Mamme No PFAS rimane necessaria anche per questo.
Insomma, quello che le Mamme No PFAS del Veneto, a cui potremmo aggiungere l’esperienza delle mamme guerriere nella Terra dei Fuochi in Campania e quello dell’attivismo delle mamme nella provincia di Siracura di fronte all’inquinamento marittimo e non solo, di cui parla il libro, reportage di Fabio Lo verso, Il mare colore veleno, ci insegnano come spesso siano le azioni locali, sostenute da esperti del territorio, a poter fare la differenza di fronte alle sfide ambientali.