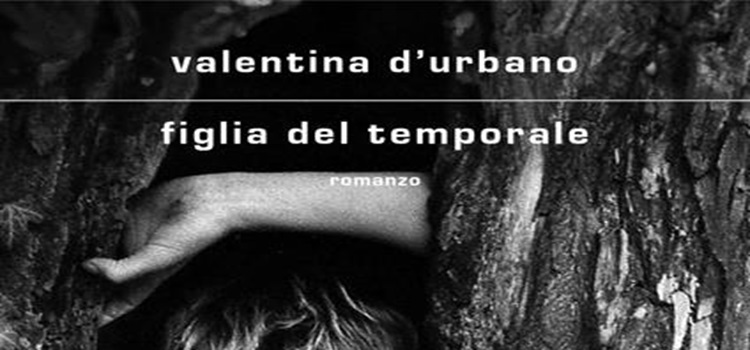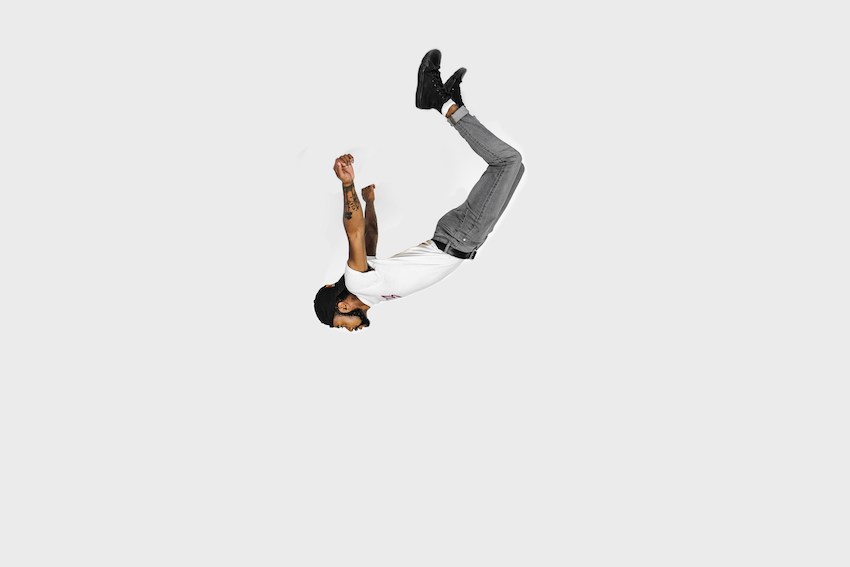Il corpo delle donne è da sempre il campo di battaglia su cui società, politica e diritti si scontrano per determinarne i limiti e le condizioni di libertà. Pensiamo solo ai fatti più recenti legati alle leggi sull’aborto, alla maternità surrogata, per non aprire poi lo sterminato dibattito legato all’attuale mancanza di tutele sul lavoro per le donne madri. La gravidanza, un processo biologicamente di genere, implica scelte e rinunce che agli uomini padri non sono richieste. Il corpo delle donne è vittima di abusi continui e dinamiche di possesso che per secoli, e ancora in molte comunità, l’hanno reso proprietà di un maschio, solitamente del padre e poi, per gentile o interessata concessione, veniva passato sotto la tutela del marito.
Convenzioni estetiche imposte dalla società determinano da sempre i corpi femminili, sottoposti a seconda dei periodi storici a pratiche costrittive e dolorose per conformarsi al modello culturale di riferimento.
“Il sesso debole” per bizzarra contraddizione ha sempre fatto paura. Per secoli definite volubili, troppo emotive, incapaci di raziocinio, isteriche, le donne andavano ammansite, recluse in contesti domestici venduti come regni di cui loro erano le indiscusse regine, limitate al ruolo sostanziale di procreatrici e domestiche. Non c’erano destini alternativi. Spesso chi si ribellava veniva punita con l’onta pubblica, nel migliore dei casi.
Sto usando il passato ma queste realtà appartengono ancora per molti aspetti alla nostra contemporaneità. Per quanto nelle società definite “moderne” appaiano attenuati e meno evidenti.
“Figlia del temporale” il nuovo romanzo di Valentina D’Urbano è ambientato negli anni ottanta , un tempo relativamente vicino alla nostra società moderna, ma in un contesto ancora arcaico, quello delle comunità montane dell’Albania del nord, dove si viveva ancora secondo i dettami del Kanun, il codice tradizionale della montagna.
Il regime comunista sovrasta e opprime, con le sue regole ferree che non possono essere trasgredite, a scandire le condizioni di vita di un villaggio umile, fatto per lo più di pastori e contadini. Ma al suo interno un altro sistema sociale, arcaico e intransigente sembra dominare ancora sulla cultura del luogo.
Ed è in questo villaggio che Hira, una ragazzina di città, si ritrova a dover vivere, dopo la morte accidentale della madre. Non ha altri parenti che possono prendersi cura di lei a parte la famiglia dello zio Ben, un montanaro rustico e duro che la accoglie in casa come una figlia e come tale deve rispettare i nuovi doveri che le competono.
Non è facile per lei abituarsi alla sua nuova vita in montagna, dopo aver abbandonato la sua amata Tirana, dove la quotidianità era scandita da piccoli privilegi e comodità che soltanto ora, nella fredda casa di legno degli zii, realizza di aver perduto per sempre.
Ma ci sono Astrit e Danja, i suoi due cugini, ad addestrarla e incoraggiarla come veri fratelli maggiori, ad affrontare tutte le nuove mansioni: dal lavare i panni nell’acqua ghiacciata del fiume, a tagliare la legna ed affrontare i lunghi inverni gelidi e i periodi di fame.
Con Astrit in particolare, Hira, allaccia un rapporto speciale e profondo, dove le parole non contano mai, ma la presenza si fa col tempo sempre più necessaria.
Astrit è un ragazzino solitario e selvaggio che sta bene solo quando scappa per inoltrarsi nella foresta più fitta, infestata di lupi e pericoli. È un luogo proibito per il Partito, perché proseguendo lungo il difficile sentiero si giunge a un tratto di roccia, oltre il quale, se si sopravvive all’ascesa, c’è il confine e la libertà.
Ma a lui non importa delle botte del padre ogni volta che torna dopo le sue fughe nei boschi e col tempo riesce a convincere anche Hira a seguirlo.
Vuole mostrargli il capanno che ha costruito. Il rifugio di cui solo loro due conoscono l’esistenza, dove possono essere totalmente se stessi, lontani da quel mondo che li schiaccia entrambi sotto convenzioni da cui non possono sottrarsi.
Grazie ad Astrit, Hira impara a domare le sue paure, a riconoscere i sentieri nascosti tra la vegetazione e a irrobustire il corpo nella natura selvatica.
Ma gli anni passano, Hira entra nell’età da marito e come è già successo a sua cugina Danja viene promessa in sposa a un ragazzo che non ha mai visto.
Il suo rifiuto di sposarsi non ha a che fare solo con la soggezione che coglie ogni ragazza del villaggio il giorno in cui viene spinta nella casa di un uomo totalmente sconosciuto. Ha più a che fare con una forza sotterranea e determinata che le impedisce di accettare una vita matrimoniale ignota, le numerose gravidanze, i parti in casa, il dolore, la sottomissione al proprio uomo, la perdita del diritto a contestare e ad esprimere il proprio pensiero, perché quello di una donna sposata non è più necessario né decoroso.
La sua natura profonda è indomita come quella di Astrit e decide di pagare il prezzo più alto, ma anche l’unico possibile, riconosciuto dal Kanun, per evitare il matrimonio combinato: diventare una Burrnesh, una vergine giurata. Hira giura davanti a suo padre e all’intera comunità di rinunciare alla sua identità di donna, al suo corpo di donna e al suo nome.
Diventa Mael e dal quel momento è riconosciuta e rispettata da tutti come un uomo ed è libera.
Impara a fumare e a bere forte nelle bettole, fino a tarda notte. Lavora come un uomo e la sua opinione sulle questioni di famiglia viene richiesta e ascoltata.
La sua libertà però, diversamente dagli altri maschi della comunità, richiede un prezzo molto alto: deve restare sola e casta.
Mael si indurisce, allontana da sé ogni tratto e atteggiamento che ricordi la sua precedente identità, reprime i propri desideri e anche quel sentimento innominabile per Astrit, spaventoso e confortevole allo stesso tempo. Nessuno li conosce meglio di quanto entrambi si conoscano, ma sono obbligati a rispettare le leggi che regolano il loro mondo, restando presenze indispensabili ma discrete l’uno nella vita dell’altra.
Finché un giorno Astrit sparisce e chi è l’unica persona in grado di affrontare la foresta per cercarlo e riportarlo a casa, dalla sua giovane e fragile sposa e alla sua comunità?
Il romanzo di Valentina D’Urbano è fluido e travolgente. Ti trascina con lei su per le strade scoscese, dove anche le jeep faticano a inerpicarsi e ci immerge in una comunità che sembra rimasta imbrigliata in un altro tempo, isolata e arcaica, dove la sopravvivenza dei propri abitanti e della loro cultura rimane ancora la priorità.
Un grande personaggio femminile domina l’intera vicenda, con il suo temperamento duro, quasi aggressivo, che comprendiamo solo più avanti, proseguendo nella lettura.
Una storia potente e ricca di simbologia sulla scelta estrema di una donna, costretta a rinnegare il proprio corpo e la propria stessa identità per essere rispettata dalla propria comunità.
Ma cosa resta, sembra chiederci l’autrice, della libertà che otteniamo solo se rinunciamo a chi siamo?
Travestirsi da uomo, cambiare il proprio nome al maschile per pubblicare un libro, fingersi uomini per andare a difendere il proprio paese, di quanti esempi e storie disponiamo per raccontare ancora le resistenze invisibili e silenziose delle donne.
Valentina D’Urbano, con “Figlia del temporale”, edito Mondadori, ce ne ha fornita un’altra: una lotta solitaria e coraggiosa dove di fronte a una comunità cieca e irremovibile, solo l’amore rimane a riconoscere e legittimare ogni corpo.