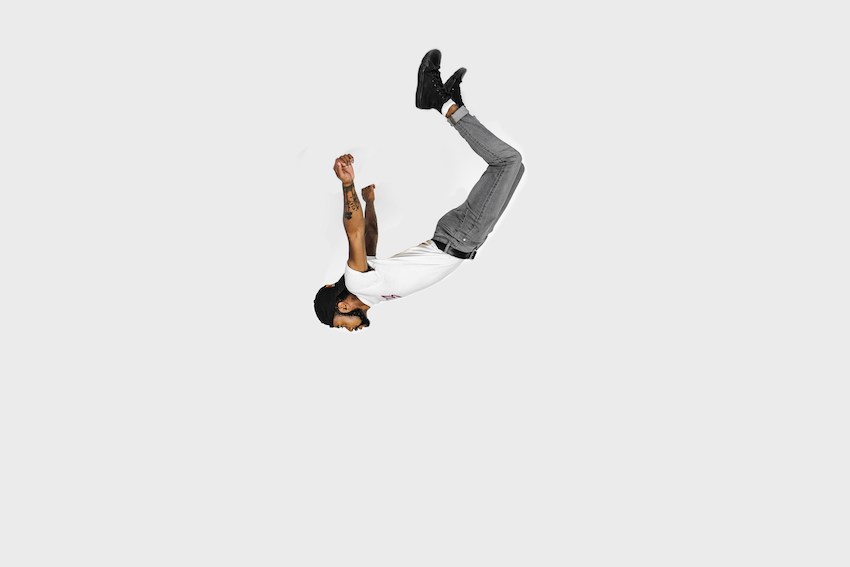Piccola ma doverosa premessa: questo articolo parla di educazione ma non riguarda solo coloro che giornalmente hanno a che fare con minori: genitori, educatori, assistenti sociali, psicologi. Lo dico per tutti coloro che immagino già con l’indice alzato, pronti a chiudere la pagina perché non interessati o direttamente coinvolti dall’argomento. Qui si parla di società e nuove generazioni, tema che potenzialmente riguarda tutti quanti. Detto questo cominciamo.
Indubbiamente i genitori sono i soggetti più spesso esposti al giudizio sulle loro pratiche o teorie educative. Se una bambina o un bambino attuano comportamenti ritenuti scomodi o maleducati, nel migliore dei casi, per non parlare di atti vandalici o violenti, che coinvolgono ragazzini e ragazzine più grandi, la responsabilità ricade al 99% sui genitori.
La famiglia rappresenta il background educativo di ogni individuo, il luogo dove i bambini osservano maggiormente i comportamenti e le azioni degli adulti di riferimento e proprio perché si tratta delle loro figure più importanti l’assimilazione avviene in maniera continua e naturale.
Questo pone le figure genitoriali più sensibili e attente in uno stato di ansia da prestazione continua, soprattutto ora, in questo periodo storico in cui teorie educative nuove si scontrano con quelle tradizionali, ancora fortemente radicate nell’ideologia sociale dilagante.
Il risultato è un grande cortocircuito, perché se da un lato siamo ormai quasi tutti d’accordo che la violenza vada respinta dalla pratica educativa, rimangono ancora molte questioni aperte tra chi sostiene che il rispetto verso un genitore lo si possa insegnare solo con l’obbedienza e l’autorità e chi con l’ascolto, l’empatia è una comunicazione efficace.
Per quanto riguarda la mia esperienza personale non ho mai avuto dubbi sul fatto che quest’ultima tipologia educativa, definita anche educazione a lungo termine, sia quella più efficace, nell’ottica di permettere alle nuove generazioni di diventare adulti consapevoli, più rispettosi delle emozioni del prossimo e delle proprie, in grado di comunicare efficacemente con sicurezza senza il timore del confronto.
Non è mai stato e continua a non essere un percorso facile per due motivi: il primo per l’inevitabile critica sociale che spesso avverto e che si ricollega sempre al pregiudizio per cui la mancanza di punizioni, urla o autorità significa mancanza di regole e di conseguenza bambini viziati che si sentono liberi di poter far tutto. Il secondo ha a che fare con le tempistiche. Questa tipologia di educazione si chiama a lungo termine proprio perché i risultati non si colgono nell’immediato: è un viaggio in cui si procede spesso a tentativi, sbagliando, ricadendo nelle dinamiche interiorizzate dell’educazione tradizionale, codificando regolarmente nuovi linguaggi e prospettive per interagire con i propri figli e le loro emozioni.
È una sfida che mette i sentimenti del genitore in primo piano, dovendo imparare loro per primi a gestire la propria rabbia, la frustrazione, la stanchezza in maniera più consapevole, sapendo di rappresentare un esempio costante per i propri figli.
È vero che non ci sono regole? Assolutamente no, le regole sono fondamentali per il benessere psicofisico dei bambini, ma devono essere chiare e ponderate. Al “no” secco e costante si può scegliere di prestare più attenzione alla richiesta, chiedersi da dove ha origine, se davvero non è possibile attuarla, se si possono trovare alternative o soluzioni.
Tutto questo lavoro di riflessione è estenuante, lo confesso, e spesso mi sono trovata io stessa in dubbio sul da farsi. Poi ho provato a ragionare sul cosa genera nel tempo e credo di aver trovato la mia risposta: rispetto.
Accogliere qualunque emozione, anche le più scomode, fa sentire l’altra persona rispettata, soprattutto se si tratta di un essere umano che sta formando la sua idea di sé stesso e del mondo.
Spiegare e far comprendere che la violenza non è mai una soluzione, invece di reagire sgridando o mettendo in punizione un bambino che ha reagito alla sua rabbia picchiando un amico o un fratello, porta nel tempo a comprendere che la violenza non si usa perché fa male e basta, non perché so che altrimenti verrò punito.
Se il bambino vede genitori che scelgono quotidianamente di non cedere all’urlo o allo schiaffo, ma che al contrario respirano, si mostrano calmi e attuano un altro modo di reagire, è inevitabile che col tempo questa modalità diventi quella più naturale anche per loro.
È facile? No, per niente.
Cedere a frasi come: io sono il genitore e mi devi portare rispetto, non puoi permetterti di trattarmi così, se lo fai ancora una volta io….ecc, è la sfida quotidiana che ho deciso di prendermi perché credo profondamente nella frase “trust the process” fidati del processo. Ha funzionato nel mio caso in altri ambiti in cui l’applicazione quotidiana e irreprensibile ha portato nel lungo periodo a far sbocciare risultati inimmaginabili. Perché non dovrebbe funzionare anche per l’accompagnamento di una piccola persona nella costruzione della sua identità?
Qualche giorno fa, la mia pedagogista e divulgatrice pedagogica di riferimento ha proposto un gioco: leggere ai propri figli alcune frasi tipiche dell’educazione tradizionale, lasciando però a loro la possibilità di concluderle come credono. Il risultato di questo gioco, ha assicurato la pedagogista, avrebbe potuto sorprenderci e devo ammettere che così è stato per me.
La frase “Finché vivi in questa casa… (fai come dico io)” è diventata: finché vivi in questa casa avrò tanti ricordi di quando ero piccola.
Vi riporto alcuni esempi delle trasformazioni che hanno effettuato i miei figli.
“Ti do io un motivo per…(piangere)”: ti do io un motivo per ballare.
“Se non smetti di piangere…(con varie varianti minacciose) è diventata: se non smetti di piangere è normale.
“Due schiaffi non hanno mai…(fatto male a nessuno) è stata completata senza tentennamenti con: due schiaffi non hanno mai valore.
“Io ti ho fatto e io…(di disfo) è diventata: io ti ho fatto e io ti cresco.
“I bambini maschi non…(piangono) è diventata: i bambini maschi non sono più forti.
“I bambini devono stare…(zitti e buoni, al loro posto, ecc..) è diventata: i bambini devono stare come sono.
È un gioco, ma penso comunque possa rappresentare un piccolo esempio significativo del pensiero che potrebbe caratterizzare gli adulti di domani, dove la minaccia non viene neppure contemplata, così come il senso di subordinazione e obbedienza. Piuttosto un generale equilibrio fra le parti, in cui l’adulto di riferimento non fa paura e non lo si ascolta solo nel rispetto di un ordine gerarchico. Un adulto che invece di reprimere può dare buoni motivi per “ballare”, in un ambiente domestico dove si collezionano ricordi felici della propria infanzia e dove “due schiaffi” non avranno mai nessun valore.
Con questa mia personale condivisione delle fatiche ma anche delle speranze che caratterizzano il mio percorso da genitore non voglio insegnare niente a nessuno. Procedo al buio, tastando i muri intorno a me per cercare la strada, non sono certo la persona più adatta a impartire lezioni.
Però credo che sia importante riflettere su quanto potere abbiamo ancora di trasmettere alle future generazioni esempi non violenti, di ascolto e rispetto reciproco.
Piccoli atti individuali non cambieranno forse le sorti dei grandi conflitti mondiali, ma posso dare vita a una società più consapevole, capace di riconoscere le ingiustizie, le dinamiche di potere, i soprusi e le prevaricazioni perché non accettabili, estranei al proprio vissuto, anche in quello dell’infanzia, dove chi doveva prendersi cura di noi non ci ha mai minacciato, umiliato o piegato con un’autorità cieca e sorda.
La stessa che in contesti ben più ampi e gravi sta portando alla morte di centinaia di migliaia di persone, nella ancora troppa indifferenza generale. Allora forse educare alla non violenza, alla fiducia, all’empatia e alla comunicazione non significa altro che educare alla pace, al saper riconoscerla, perpetuarla e rivendicarla, sempre, a partire dalle nostre case.