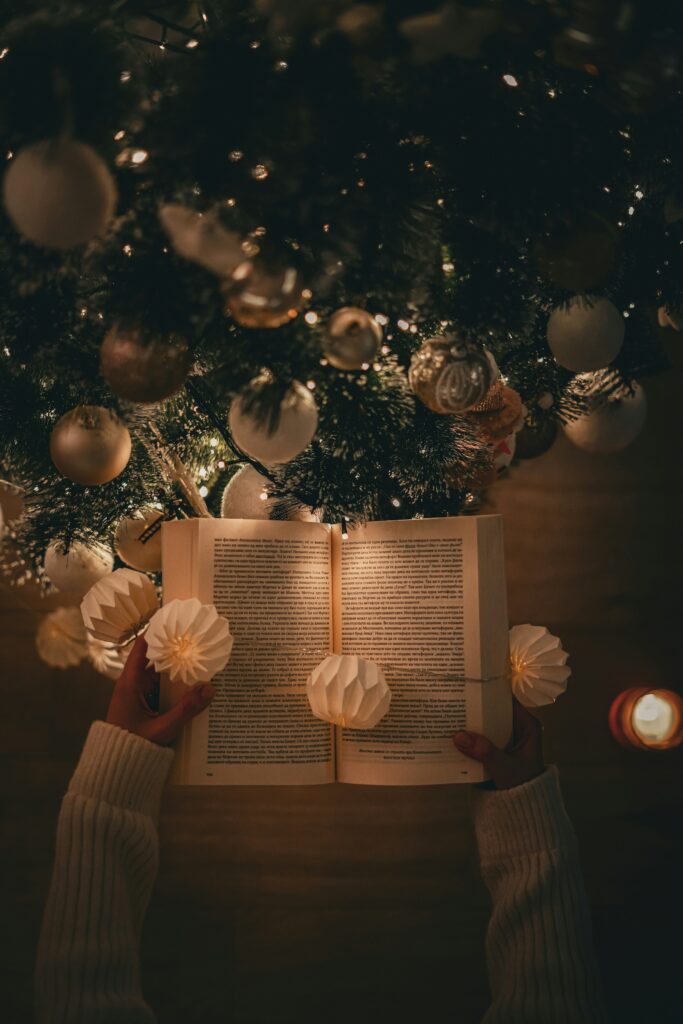Paolo Barcella è docente di Storia contemporanea all’Università di Bergamo. Ha pubblicato diversi studi sull’emigrazione italiana in Svizzera e una biografia di Leonardo Zanier, un eminente rappresentante di questa emigrazione.
Quest’anno ha pubblicato per l’editore Carocci La Lega. Una storia di cui Sconfinamenti si è recentemente occupato (https://sconfinamenti.info/una-storia-per-capire-la-lega/)
Su quest’ultima pubblicazione ha cortesemente accettato di rispondere ad alcune domande di approfondimento.
Prof. Barcella, siamo abituati oggi a parlare della Lega come di un’organizzazione unitaria radicata soprattutto nel Nord Italia. In realtà inizialmente ci furono diverse leghe, prima di tutto quella veneta: come si spiega la relativa omogeneizzazione in un soggetto unico di queste diverse realtà?
La fusione delle prime organizzazioni leghiste in un unico soggetto politico, la Lega Nord, fu opera di Umberto Bossi che si diede sempre, sin dall’inizio, l’obiettivo di fare della sua creatura politica – la Lega Lombarda – una forza di rilevanza nazionale. In questo senso, la sola via percorribile era la costruzione di una federazione di forze autonomiste regionali, nel quadro di un programma che puntasse alla riforma delle istituzioni in senso federalista, per affidare alcuni livelli del potere centrale alle regioni. Quando, prima della discesa in campo di Berlusconi e dopo il collasso politico del 1992, la Lega pareva destinata a diventare primo partito nel paese, Umberto Bossi, Gianfranco Miglio e i vertici leghisti dell’epoca elaborarono un progetto di espansione al Centro e al Sud, mirante alla creazione di leghe macroregionali per quei territori. L’autonomismo, il regionalismo, il federalismo apparivano di conseguenza nei programmi e nella retorica leghista degli anni Ottanta e dei primi anni Novanta come parole pigliatutto, concetti a geometria variabile, significanti a cui si poteva di volta in volta assegnare il significato più funzionale alle esigenze del momento. Bossi fu molto abile nell’adoperare strategicamente quelle parole per arrivare al governo. La Liga Veneta e l’Union Piemonteisa vennero invece divorate dal progetto bossiano, anche a causa della loro maggiore fedeltà ai principi e ai contenuti di verità regionalisti, nei confronti dei quali, invece, Bossi ebbe sempre un approccio strumentale e opportunistico.
Fatta salva l’esigenza di comprendere le radici profonde del fenomeno leghista, non ritiene che i suoi esponenti abbiano comunque introdotto elementi di imbarbarimento nel linguaggio politico, contribuendo anche ad acutizzare le tensioni sociali?
Nel corso degli anni Settanta e Ottanta, i partiti entrarono in crisi e con loro il sistema politico nel suo insieme, con i suoi linguaggi e le sue forme. Una delle critiche più comuni rivolte ai funzionari di partito dell’epoca era quella di parlare il “politichese”, un linguaggio supposto esoterico, ingannevole, incomprensibile per la gente comune. Tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, poi, cambiò il modo di trattare la politica in televisione, lo strumento tecnologico che si stava imponendo come luogo di discussione e dibattito. Finivano in soffitta programmi “ingessati”, come “Oggi al parlamento”, e comparivano i primi programmi ad alto tasso di spettacolarizzazione della politica: si assisteva a una semplificazione dei linguaggi, che si adeguarono ai tempi e alle forme della comunicazione televisiva. In questo contesto, Bossi si dimostrò assai abile nell’interpretare lo spirito del suo tempo. Con un’estetica popolare – si pensi alle uscite in canottiera – e un linguaggio molto rozzo e diretto, riuscì ad apparire seduttivo per larghi strati di elettorato settentrionale politicamente disorientato dalle molteplici crisi che l’Italia stava attraversando. La trivialità dei suoi riferimenti al sesso bucavano lo schermo – pensiamo al celebre motto “La Lega ce l’ha duro”, o al caso Margherita Bonver, ministra socialista del primo governo Ciampi, alla quale Bossi si rivolse pubblicamente per ricordarle che la Lega era armata di “manico”, ossia di viril membro. Tali espressioni, in bocca a un parlamentare di primo piano, suonavano come una novità assoluta, ma erano linguaggio corrente in larghi strati di popolazione provinciale, che di conseguenza si identificava facilmente nel senatore varesino. Tutto questo per dire che non considero Bossi come il responsabile dell’involuzione del discorso politico: penso piuttosto sia stato uno dei sintomi più precoci e degli interpreti più evidenti di quell’involuzione.
Per rimanere sulla questione di genere, mi permetto di citare Flavia Perina che ha scritto: “Le donne per la Lega non sono un genere o un sesso titolare di particolari questioni o di specifici diritti ma Heimat, patria, focolare, radice della comunità”. Condivide questo giudizio?
Sin delle sue prime dichiarazioni pubbliche, Umberto Bossi ha sempre sottolineato come la famiglia tradizionale fosse centrale nella sua visione politica. Sulla famiglia tradizionale, scriveva il senatore nel suo “Vento dal Nord” (libro propagandistico del 1992), si doveva basare la nuova società federalista. Da questo punto di vista, la Lega è sempre stata una forza di chiara marca conservatrice. Negli anni Ottanta, le donne attive nella Lega erano poche e, spesso, erano mogli di militanti. In seguito, sono apparse alcune figure femminili con ruoli di un certo rilievo, tuttavia le figure portanti nelle varie stagioni del partito – Roberto Calderoli, Roberto Maroni, Mario Borghezio, Roberto Castelli, Francesco Speroni, Marco Reguzzoni, Giancarlo Giorgetti, Luca Zaia, Flavio Tosi – sono tutti uomini. E, non per caso, le due donne che hanno ottenuto più influenza di lungo periodo nella Lega, ovvero Rosy Mauro e Manuela Marrone, lo hanno fatto negli anni della malattia di Bossi, stringendosi attorno al capo, a tutela della sua salute e della sua immagine, in una dimensione contraddistinta da elementi fortemente familistici.
Tornando alle radici e a quanto da lei sottolineato in precedenza, ovvero che sin dall’inizio Bossi si era posto quale obiettivo quello di rendere la Lega Lombarda una forza di rilevanza nazionale, in che modo si spiega il parziale fallimento della “nazionalizzazione” della Lega da parte di Salvini?
Più che nella “nazionalizzazione”, ci sono fattori di fragilità nel progetto salviniano in sé e si comprende bene comparando le due stagioni leghiste. Bossi riuscì nell’operazione di occupare politicamente i territori del Nord, costruendo una sub-cultura politica verde. Raggiunse l’obiettivo sviluppando reti, legando localmente per interessi economici imprenditori ad altri attori sociali; lavorò alla formazione di un paio di generazioni di amministratori comunali. La Lega, tra gli anni Novanta e i primi Duemila, diffuse centinaia di sedi, animò iniziative pubbliche, creò piccole, ma numerose, associazioni militanti, giunse al punto da riuscire a organizzare decine di “feste padane”, nei mesi estivi, che sostituirono, in tanti comuni lombardo veneti, le storiche “feste dell’Unità” del Partito comunista. Questo obiettivo venne raggiunto con un concreto lavoro territoriale pluriennale. Chiaramente ci sono stati, nel corso degli anni, momenti più o meno favorevoli per il partito, ma la Lega di Bossi aveva il suo zoccolo duro pedemontano e mantenne, fino al 2012, alcuni territori del Nord sempre sotto controllo, continuando a eleggere sindaci e consiglieri, anche nei momenti più duri. Al contrario, l’operazione di “nazionalizzazione” salviniana si è consumata tutta nei media e ha tratto la sua linfa da una abile serie di operazioni di comunicazione politica online, orchestrate da Luca Morisi. L’espansione fisica a Sud, incarnata dall’apertura di sedi del partito, contava su personalità che provenivano da tradizionali ambienti di destra, facili a cambiare referente politico in caso di indebolimento del leader. Tra il 2013 e il 2019, in un momento di crisi che investiva la destra berlusconiana, Salvini ebbe modo di imporsi e, durante la sua stagione ministeriale, orientò brutalmente l’ecosistema mediatico, generando una forte bolla di consenso. Dopodiché, quando la bolla social-mediatica è esplosa, s’è sgretolata la prima stagione salviniana.
Nel primo governo Berlusconi serpeggiava una forte tensione fra l’esasperato autonomismo della Lega di Bossi e il nazionalismo accentratore di Alleanza nazionale. Pensa che queste tensioni si possano presentare anche fra le forze politiche che compongono l’attuale alleanza di destra in caso di vittoria elettorale il prossimo 25 settembre?
Più che altro credo che la stessa Lega di Salvini sarà attraversata da tensioni interne importanti. La svolta nazionalista salviniana non era stata digerita da tutto il partito, nemmeno negli anni in cui il nuovo segretario aveva l’aria di un indiscusso condottiero. Molte tensioni tra amministrazioni locali e segreteria federale si sono accentuate anche in ragione dei problemi generati dal Covid, soprattutto nelle province lombarde e venete. Credo che, in un modo o nell’altro, nei prossimi mesi queste tensioni riemergeranno. Molto dipenderà dall’andamento delle elezioni, dal peso effettivo e dai rapporti di forza che si stabiliranno tra Lega e Fratelli d’Italia. Tuttavia, occorre tenere conto che, ai tempi del primo governo Berlusconi, le tensioni tra Bossi e Fini dipendevano anche dalla questione antifascista. Bossi aveva creato una nuova forza di marca conservatrice – si pensi al tema della famiglia, all’omofobia diffusa, alla visione padronale dello spazio pubblico e sociale – ma antifascista, perché anticentralista e antimeridionalista. L’assunzione di una retorica antifascista era per Bossi opzione necessaria, perché, nei mondi operai del Nord a cui puntava, era presente una forte sensibilità a proposito della “pregiudiziale antifascista”. In questo senso, il quadro attuale è completamente cambiato e la “pregiudiziale antifascista” non è certo un tema che più influire sugli equilibri interni alla destra italiana del 2022.
Un’ultima domanda: lei ha studiato a fondo l’emigrazione italiana in Svizzera, a partire dai flussi migratori provenienti dal Nord Italia; ci può aiutare a capire i motivi della mancanza di empatia o addirittura il rancore sociale di molti emigrati o ex emigrati verso i meridionali prima e gli stranieri poi che si sono insediati nelle regioni settentrionali della Penisola?
Una parte degli emigrati italiani che hanno vissuto la condizione del “Gastarbeiter” hanno interiorizzato l’idea che il migrante dovesse essere subalterno ai processi economici, politici e sociali del paese in cui andava a lavorare. Non era così per tutti, certo, poiché furono migliaia anche quelli che si impegnarono per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori italiani all’estero. Tuttavia, molti italiani trascorsero anni in Svizzera, o in Germania, o in Belgio, come lavoratori stagionali o annuali, vivendo talvolta nelle baracche o nei convitti, accanto a cantieri o fabbriche, con limitazione nei diritti politici e di associazione sindacale. E lo fecero pensando che fosse giusto così, sentendosi ospiti in casa d’altri. Molti di loro – soprattutto quelli che rimasero più a lungo in condizione di precarietà, con il solo obiettivo di guadagnare molto per rientrare prima possibile in Italia – una volta rientrati al paese d’origine non ritennero che ai migranti meridionali o stranieri si dovessero riconoscere i diritti politici e di cittadinanza di cui, nel loro passato all’estero, non avevano goduto. Semplicemente, a quel punto, si sentivano padroni di casa, nel pieno diritto di schiacciare gli altri in posizione di subalternità. E, nei confronti di chi chiedeva diritti per i migranti, maturavano risentimento. Non è un caso, quindi, se le vallate venete e lombarde, a più alto tasso di emigrazione verso i paesi del centro nord Europa, furono anche culla dei leghismi.